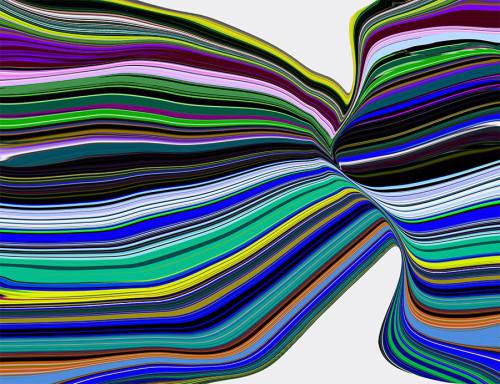
Angelo Andreotti è nato nel 1960 e vive a Ferrara, dove dirige i Musei di Arte Antica e Storico Scientifici. È direttore della rivista on-line Museoinvita. Dopo la laurea in Filosofia si è sempre occupato di linguaggi artistici, curando mostre e scrivendo saggi su arti visive, museologia e letteratura. Per la poesia ha pubblicato: Porto Palos, Book, 2006; La faretra di Zenone, Corbo, 2008; Nel verso della vita, Este, 2010 (introduzione di P. Vanelli); Parole come dita, Mobydick, 2011; Dell’ombra la luce, L’arcolaio, 2014 (introduzione di M. Bianchi e postfazione di D. Demetrio); A tempo e luogo, Manni, 2016. Inoltre ha scritto alcuni racconti raccolti in Il guardante e il guardato, Book Salad, 2015 (introduzione di F. Ermini e postfazione P. Garofalo). È membro del gruppo fondatore dell’Accademia del Silenzio, per la quale ha prodotto la riflessione sulla parola poetica Il silenzio non è detto. Frammenti da una poetica, Mimesis 2014. Sue poesie sono presenti in antologie e riviste.

Appunto di Angelo Andreotti sul «Silenzio»
Il silenzio è l’aria che la parola poetica respira (inspira espira). Qui si gioca la differenza.
Che sia solo una parola, o un insieme di parole, poco importa. Anche una parola sola, pur essendo la stessa, suona differentemente come da una dimensione ulteriore, che qui diciamo “silenzio”, e qui si manifesta prendendo corpo nel suono.
Perché la voce è un po’ come il volto: ha le rughe degli anni e delle preoccupazioni, i colori della gioia, le tenebre del dolore. Lo sguardo. La luce degli occhi. Arrossisce. Si china e s’inchina…
Il suono dà corpo a quell’emozione che la parola da sé non ha. Se non ci fossi io o tu a dirla, e tu o io ad ascoltarla. A farne ciascuno a nostra volta respiro (inspirazione, espirazione).
Il silenzio accade solo in relazione a un’esperienza con l’altro, e anche con sé stessi come altri da sé.
Ascendenza, ictus, discendenza.
La sonorità del verso (la sua musica, la sua cantabilità o, più semplicemente, la sua vocalità) non è un’altra lingua: è il compimento della lingua, la sua epifania, le sue ali in volo sui paesaggi del silenzio.
È l’aria che poggiandosi in terra e alzandosi al cielo si dà un corpo sostenendo quel volo, dal quale si traguarda ciò che è oltre il limite del senso.
L’uccello di passo non si interroga sull’aria che sostiene la sua migrazione. Vola, con l’urgenza di raggiungere un altro posto.
Le sue ali si muovono su un niente che tuttavia ha sostanza. Ed è sostanza leggera, invisibile.
È la stessa sostanza del suo respiro. È una sostanza che di per sé non ha sostanza, ma l’acquista dal sapere del suo corpo, che sa come muovere le ali, disporre in linea la sua forma, assecondare l’inconsistenza dell’aria trovando il giusto ritmo del battito d’ali, e assecondando questo con il battito del suo cuore, affinché il volo non sia fatica, affinché quell’aria che è veicolo del suo volo non sia voragine della sua caduta.
Il senso del volo non è dove andare, ma è come farlo.


Commento impolitico di Giorgio Linguaglossa
Angelo Andreotti non «referenzializza», se così possiamo dire, il letterario, se consideriamo con questa dizione il genere innico che va dal Canti di Leopardi e gli Inni di Hölderlin ai giorni nostri che abitano il post-moderno e la post-poesia, ma non nel senso di dire l’equivalente o il complementare di un territorio linguistico quanto di dire oggi il campo di devalorizzazione del poetico, dato che la «risposta poetica» di Angelo Andreotti non è il «letterale», ne deriva che ciò che non fa più questione è qui trasfigurato in figuratività e in figurazioni enigmatiche in quanto l’enigmatico è ciò a cui è rivolto il discorso poetico, quel lato che è nascosto alla dicibilità per una latenza implicita della forma-poesia, che si esprime in «variazioni», in allusività e in indirezioni di significato. Del resto, il carattere «astratto» di queste poesie non sarebbe altro che il corollario stilistico quale «legge di complementarità» che regge questa genere di ricerca letteraria. Ciò è proprio di un discorso alto-retorico che incorpora, nel testo, il contesto implicito dando al lettore una impressione di metaforizzazione complessiva del testo.
È una ricerca poetica che «chiude» necessariamente rispetto a generi attigui come la poesia-confessione la poesia degli «oggetti» del quotidiano, la poesia dell’io giacché quegli «oggetti» colà leggibili, nel quotidiano, sono, nel contesto della poesia andreottiana diventati illeggibili, sono qui correlati in un nucleo imaginale, la catena paradigmatica: notte, pioggia, bufera, oscurità, ombra, finestra, ombra, casa, soglia; con i corollari: immenso, immobilità, neve, con la figura simbolica della finestra: «Dalla finestra il bosco scuote i rami / scaccia gli uccelli»; il «paesaggio» che compare e scompare ad intermittenza, etc.. L’indirezione referenziale regna, dicevamo, sovrana, ciò che accentua l’aspetto di inverosimiglianza complessiva e di «risonanza» di questo universo poetico.
C’è un pudore, una reticenza alla nominazione delle «cose», giacché qui non ci sono veramente delle «cose» riconoscibili ma astrazioni, oggetti rarefatti, eidola ridotti alla loro pura essenza nominabile per elusione e indirezione. In questa ricerca di una nominazione allusiva e indiretta il logos diventa necessariamente elusivo, cangiante, polisillabico, ambiguo e come domesticizzato dallo sguardo.
I testi del poeta ferrarese non dicono mai «ecco, questo è il problema», «questa è la cosa», «questo è ciò ch’io voglio» e così via, insomma, non dicono mai le cose in modo diretto; Andreotti finzionalizza tutte queste domande in quanto le presuppone implicite nel suo approccio al discorso poetico, nella stilizzazione tematica e figurativa.
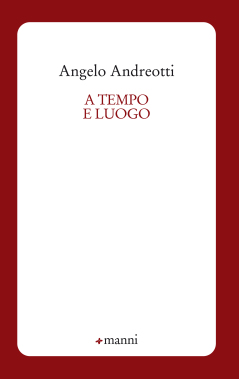

Dieci poesie di Angelo Andreotti
II
Nulla noi conosciamo del mare, solo il fiume,
il nostalgico fiume, ne ricorda qualcosa
e torna all’origine come fosse il futuro
penetrando le falde di una terra che gli è sposa.
Più lontano ancora del mare c’è la memoria,
la sempre presente, la sempre assorta in sé stessa,
e nella sua immensità le nostre mani tremano
appoggiate a scalmi consunti da tanto andare
tra una sponda e l’altra, tra rimpianti e desideri,
ricordi e speranze.
Noi in continuo movimento
siamo presi da un corso di cui ignoriamo il senso.
Perciò ti dico che il futuro è un tempo presente,
un tempo che solo il passato può immaginarsi,
oppure lo può il sognare di un dio meditante
per dimorarvi le forme di ciascun inizio,
per dare una direzione
non certo un itinerario.
Ma ogni dio è disumano, e sempre a noi si accosta
con quel passo lieve di piedi nudi sull’erba
e l’algida inesistenza dell’ovunque esistente
affinché vada compiendosi il nostro stare al mondo.
.
III
Noi non sappiamo se il mondo sia nostra dimora
o uno straniero inquieto che abbiamo ospitato,
così dalla soglia ci illudiamo di distinguere
il dentro dal fuori, mentre tutto è in ogni luogo.
Il passo che calcammo, e l’orma che lasciammo,
sono un tutt’uno con il sentiero da percorrere
che solo il tempo in sé stesso divide e distingue.
Cosa ci tenga distanti dal mondo noi
non lo sappiamo.
Forse quello spazio teso fra parole e cose,
forse il continuo avviarsi di ciò che è in ciò che sarà
e la permanenza di ciò che è stato in ciò che è.
Può darsi anche sia per la nostra fragilità,
quest’incauta indulgenza che ci concediamo
confondendo nel presente l’eterno dall’immortale,
o magari è la vita che trasmuta le sue forme
facendoci chiedere dove stia andando
tutto il tempo che è passato
con tutto ciò che si è preso.
È che in fondo tempo e fiume si assomigliano:
entrambi scorrono
restando
nel punto esatto da cui se ne sono andati.
.
V
Sarà questo stanco sciacquio, questi occhi puntati
sui nudi fianchi dell’argine, su fogli di aria
che si sovrappongono fluttuando come veli,
sarà che a riva il fiume ci fa sentire qui
da tanto tempo, e in così tanto tempo
non riuscire ancora a capirne quel suo mutare,
continuo, nell’insaziare la sete del mare.
Sarà che il tempo non può più essere il nostro spazio,
e quindi si arrende alla sua stessa capacità
d’illudere direzioni
geometrie
destini,
sarà che in quelle stanze abbiamo già consumato
tutto il tempo trascorso lì, e mai più ovunque.
Sarà per quest’aria infusa di dimenticanze
che già stare insieme è un abbraccio, quasi l’ultimo
con il quale espiamo il nostro continuo andarcene,
languido come un’onda,
violento come un’onda,
sospeso come un’onda,
furtivo come un’onda…
VI
Ma ora che il fiume è un giardino autunnale,
dove un giallo intinto di rosso smeriglia l’acqua
sgualcendola come un sudario lavato di fresco
e poi steso da un gennaio dal cuore confuso
sui fili di fumo di quest’aria limacciosa…
In questo giardino dall’acutissima quiete
ogni istante in sé è perfetto, imperfetto
ci appare l’infinito
l’immenso
l’eterno
che noi pretendiamo di riassumere in concetti.
E tuttavia, nell’agonia del nostro pensiero
ci consola il girare lo sguardo di fianco,
verso quel cespuglio
da dove si leva all’udito un volo dal nulla,
la sua presenza invisibile, la sua evanescenza
e il nostro cercare lo scopo che ci riguarda…
… la sua tangibile assenza dal tempo, l’attesa.


XI
Io non so se il tempo sia un dio, un essere alato,
l’imperfetta ostinazione di un cronometro,
oppure una menomazione dell’eternità
in bilico tra misericordia e redenzione,
quello che so è di averne un sentimento inafferrabile.
Curvo è il tempo, e curva è la vita,
in apparenza nascosti l’uno dentro l’altra,
entrambi intenti a unire fine e principio
senza che fine e principio giungano a toccarsi.
Noi, stretti tra le spire di questa via perenne,
in fondo nulla chiediamo
e nulla vogliamo
se non quel po’ di spazio tra vita e tempo
che ci consenta di schivare il dolore
della mancanza, dell’assenza, del provvisorio.
Ma il dolore è il prezzo pagato agli dei
che non sanno,
se non da noi,
la gioiosa esultanza di ogni inizio
e la sconcertante ignoranza del dopo
che sbreccia i recinti del possibile.
.
XII
Quando ci saremo persi saremo vicini
e non sarà più tardi per la misericordia,
per una tavola apparecchiata, o un abbraccio
proteso fin dove arrivano le mani,
molto più in là di quanto può lo sguardo incapace.
A tempo e luogo tutto accade, e poiché accade
nulla accade invano, e mille volte ritorna
in ricordi che noi riassaporiamo, oppure
che setacciamo ancora e ancora
per comprendere
dove abbiamo perso il filo, dove l’occasione,
messi all’angolo dal dubbio che mai chiariremo
se il perdere
anziché una sconfitta
non sia stata la cosa giusta.
Con la pervicacia dell’onda che torna a riva
viviamo più giorni di quanti ne abbiamo trascorsi.
Abbiamo vissuto quel passato, e viviamo
i tanti presenti che tornano a ricordarlo,
e ogni volta è reale il sentimento, l’emozione,
e ogni volta è viva la ferita, o la gioia.
.
XVIII
Essere fiume,
quell’albero,
questa casa,
la pietra nell’ombra, un’altra al sole, la pioggia
e il vento, le nuvole le loro forme e i colori all’alba
al tramonto, di giorno e nella notte che verrà,
l’odore tra noi e il fiore, essere quel rumore
quando il rumore ci sorprende, e anche il silenzio
mentre la voce tace dopo aver molto detto,
essere il sentire di essere man mano che è.
Se il mutamento fosse un’illusione del tempo?
Se il tempo è movimento nulla va mutando
e tutto è ciò che è.
Però noi ricordiamo, noi
sappiamo di essere stati, eppure anche questo
è un momento presente.
La memoria è presenza
fin quando racconta, e comunque ciò che è stato
rimane disciolto nella chimica del tempo.
Le case ricordano, e anche i luoghi lo fanno:
tengono per sé ogni cosa che lì si è compiuta.
.
XX
Che l’unico tempo a noi concesso sia il presente
non fa del presente il tempo, poiché esso si estende
ben oltre l’opaca sostanza del quotidiano.
Il presente ne è soltanto l’occulto custode,
come del fuoco lo è la brace, non il ramo secco,
né la fiamma che del fuoco è l’effimera presenza.
Noi continuiamo a essere dove siamo già stati
e già siamo là, dove andremo, poiché viviamo
anche la vita che avremo potuto vivere:
più forte l’esperienza
più vasta l’immaginazione.
Passi sulle scale di una casa che scale non ha
salgono e scendono, percorrono vite perse
nei bivi che non prendemmo, e tuttavia restano
come echi nel tempo, salendo e scendendo scale
che la casa potrebbe avere
ma non ancora.
.
XXIX
Ora, suona come in una stanza, la voce.
Verso la voce viene un tramestio di passi
ma da un altro tempo. Sopraggiunge, si affianca.
Voce e passi non si incontrano: troppo distanti
si mancano, eppure nella casa convivono.
Lasciarsi prendere è il segreto, abbandonarsi,
varcare la soglia e ribellarsi allo sgomento
per quella bianca bonaccia dove si consuma
la cruda somiglianza tra l’Assoluto e il Nulla,
e allo sgomento preferire la meraviglia
che sempre accompagna la coscienza
per la presenza delle cose.
.
XXX
E tuttavia consegnarsi all’improvvisazione,
interrompere la sequenza del tempo, l’ordine
frenetico, quel suo premere sulla vita,
quel suo restringere tutto nell’immediatezza,
quel suo portarci via in un’unica direzione,
e allora sovvertirne il corso, forse ignorarlo,
affinché perdendo il verso ne resti il frammento
che dalla memoria emerge e dischiude il presente,
il luogo in cui tutto accade afferrando ciò che scivola,
poi spostare il passo per ignorare il sentiero
e trovarlo in un posto differente, vegliare
vigili sui segni che di tanto in tanto vengono
chiamando da un altro tempo
ma nella stessa stanza.
