
Giorgio Linguaglossa
19 febbraio 2018 alle 10.00
L’ESTRANEAZIONE È LA CATEGORIA BASE DELLA NUOVA POESIA
L’estraneazione è l’introduzione dell’estraneo nel discorso poetico; lo spaesamento è l’introduzione di nuovi luoghi nel luogo già conosciuto; il mixage di iconogrammi e lo shifter, la deviazione improvvisa e a zig zag sono gli altri strumenti in possesso della musa di Mario Gabriele. Queste sono le categorie sulle quali il poeta di Campobasso costruisce le sue colonne di icone in movimento. Il verso è spezzato e interrotto, segnato dal punto e dall’a-capo è uno strumento chirurgico che introduce nei testi le istanze «vuote»; voglio dire che i simboli, le icone, i personaggi sono solo delle figure, dei simulacri di tutto ciò che è stato agitato nell’arte e nella poesia del novecento, non esclusi i film, anche quelli a buon mercato, le long story, le short story… sono flashback a cui seguono altri flashback che magari preannunciano icone-flashback… non ci sono né domande, come invece avviene nella poesia ultima di Gino Rago, né risposte come avviene, a volte, in alcune mie composizioni.
Altra categoria centrale è il traslato, mediante il quale il pensiero sconnesso o interconnesso a un retro pensiero è ridotto ad una intelaiatura vuota, vuota di emozionalismo e di simbolismo. Questo «metodo» di lavoro introduce nei testi una fibrillazione sintagmatica spaesante, nel senso che il senso non si trova mai contenuto nella risposta ma in altre domande mascherate da fraseologie fintamente assertorie e conviviali. Lo stile è quello della didascalia fredda e falsamente comunicativa che accompagna i prodotti commerciali e farmacologici, quello delle notifiche degli atti giudiziari e amministrativi; Mario Gabriele scrive alla stregua delle circolari della Agenzia dell’Erario o delle direttive della Unione Europea, ricche di frastuono interlinguistico con vocaboli freddi e distaccati, dal senso chiaro e distinto. Eppure, proprio in virtù di questa severa concisione referenziale è possibile rinvenire nei testi, di soppiatto e appena visibili, come nella filigrana delle banconote, delle fraseologie spaesanti e stranianti appena percettibili, appena ridondanti.
Ma tutto questo armamentario retorico era già in auge nel lontano novecento, qui, nella poesia di Gabriele non c’è nulla di nuovo, eppure è nuovo, anzi, nuovissimo il modo con cui viene pensata la nuova poesia che abbiamo denominato nuova ontologia estetica. È questo il significato profondo del distacco della poesia di Gabriele dalle fonti novecentiste; quelle fonti si erano da lunghissimo tempo disseccate e producevano foglie secche, pagine immobili, elegie mormoranti, chiacchiere da bar dello spot nel migliore dei casi, tutta quella tradizione (lirica e antilirica, elegia e anti elegia, neoavanguardie e post-avanguardie) non producevano più nulla che non fosse epigonismo, scritture di maniera, manierate e lubrificate.
Mario Gabriele dà uno scossone formidabile all’immobilismo della poesia italiana degli ultimi decenni, e la rimette in moto… È un risultato entusiasmante… che mette in discussione tutto il quadro normativo della poesia italiana…
Altro scossone formidabile lo dà la poesia-pensiero di Gino Rago che ruota attorno ai pensieri primordiali dell’homo sapiens: il vuoto, l’essere, l’esistenza, il nulla, il senso dell’essere e della poesia con l’ausilio del traslato e della metafora…
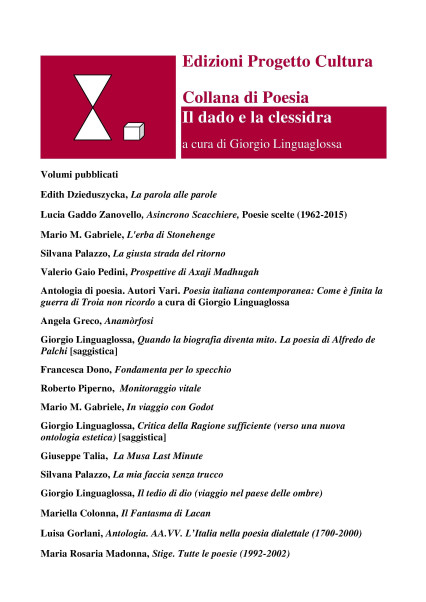
Donatella Costantina Giancaspero
19 febbraio 2018 alle 19:10
Ho qui il libro di Linguaglossa, Critica della ragione sufficiente (verso una nuova ontologia estetica), 500 pagine, l’ho sfogliato di qua e di là, ho iniziato a leggerlo… è un po’ una summa e un riepilogo di alcuni scritti che erano comparsi sull’Ombra delle Parole che affrontano una serie di gigantesche problematiche che galleggiano in questi tempi di debolismo e di epigonismo diffusi. Erano molti decenni (quanti non saprei dire, ma credo che bisogna risalire agli anni settanta) che nelle lettere italiane non venivano sollevate tante e tali questioni: il bello, il vuoto, il nulla, l’esistenza, il tempo interno delle parole, il tempo esterno, lo spazio, la spazializzazione e la temporalizzazione, l’Evento (Ereignis) in arte e tante altre questioni apparentemente slegate e fortuite come il selfie, l’autoritratto, il problema dell’inconscio nella “nuova poesia”… insomma, tali e tante questioni che messe assieme in un libro-zibaldone non si erano mai viste in un libro di critica (militante) in Italia.
E c’è da dire che molte cose sono chiare e lampanti, chiare e distinte direbbe Cartesio, ad esempio la questione dell’essere e dell’essere delle parole, la questione del linguaggio e quella del linguaggio poetico, la questione mandel’stamiana del discorso poetico. Un incredibile excursus su tutte le principali questioni oggi sul tappeto del fare poesia. Perché è bene dirlo con chiarezza: senza affrontare queste questioni non si può scrivere oggi poesia di una qualche serietà, perché è bene che un poeta sia anche un intellettuale e non soltanto un chiacchierone ciarlante, una cicala parlante e scrivente che scrive sulle margheritine e sui broccoli del proprio orto botanico.
Donatella Costantina Giancaspero
20 febbraio 2018 alle 20.30
cari Mario e Antonio,
che Nicolò Ammanniti e Aldo Nove abbiano abbandonato la scrittura in versi la considero una autentica fortuna, quanto a Giorgio Barberi Squarotti, dai, siamo seri, uno che scriveva migliaia di lettere ogni anno piene di elogi a chiunque gli inviasse pseudo poesie, a mio modesto avviso non è una persona attendibile e seria, magari sarà stato serio in altri campi, ma in poesia no, era uno dei tantissimi che voleva accaparrarsi il benvolere di tutti. Ridicolo. Intendo questa acquiescenza alla massa di aspiranti poeti sempre alla ricerca di riconoscimenti e approvvigionamenti. Penso che sia ora di finirla con i complimenti rivolti a tutti, e bene fa l’Ombra che non risparmia critiche a nessuno quando lo ritiene opportuno…
Bisogna ritornare ad essere seri in questo Paese e a non diramare complimenti a nessuno, anche a costo di attirarsi antipatie… la stagione degli scampoli è finita.
*
20 febbraio 2018
Gino Rago
L’atto poetico nel vuoto*
«Ci interessa la forma del limone
non il limone».*
*[Questo scrissero sul manifesto formalista quegli artisti
Nell’ammutinamento sui battelli del figurativismo
E del narrativismo.
Ma fu sera e mattina sulla Forma].
I
[…]
Un reziario nell’arena
Con un altro reziario un po’ più antico
Ma nella stessa arena, verso chi tridenti e reti?
Chi o cosa vogliono irretire, senza corazza ed elmo?
Il Vuoto? Vogliono imprigionare il Vuoto
con un balzo estetico.
Perché la bellezza è nel vuoto?
[…]
I due reziari all’unisono: «Perché se sei nel vuoto,
se davvero ti senti nel vuoto, devi agire prima che il vuoto ti risucchi…
È il gesto che salva. È l’urto tra l’atto poetico e il vuoto
che genera lo spazio e il tempo,
perché il vuoto e il nulla non coincidono affatto.
La forma-poesia non è l’inizio
ma il risultato dell’urto dell’atto nel vuoto che fluttua.
Perché il vuoto si può costruire, come al silenzio si può insegnare a parlare,
ma occorrono le parole-stringhe a cinque dimensioni».
II
Roma. Due reziari seduti a un tavolino.
Il bar di via Gaspare Gozzi [la linea B della Metro sferraglia].
A una parete gli occhi e le rughe di Samuel Beckett.
Il barista si avvicina con due tazze fumanti, sorride.
L’uomo somiglia a José Saramago, dice: «Vi ammiro,
voi conoscete la doppiezza delle parole, nelle vostre poesie una parola
tira l’altra e con la stessa parola si può dire la verità».
[…]
– «Una parola davvero scomoda», pensa l’interlocutore non visibile
che siede qui accanto nel bar –
[La verità fa rima con varietà], questo lo affermava il Signor K. nella omonima
poesia di Linguaglossa, dove il Signor K. fuma
un sigaro italiano e cincischia con il revolver…
[…]
«Ma voi non siete ciò che dite, siete dei truffatori, siete…
il credito che le vostre parole vi danno».
* [L’atto poetico nel vuoto è stato costruito come dialogo fra due amici poeti
(Gino Rago e Giorgio Linguaglossa) alla maniera della Nuova Ontologia Estetica) nel quale il parlato fra i due gioca un ruolo estetico decisivo.]


Luigina Bigon
20 febbraio 2018 alle 22.10
Vuoti
Nel castello meteore psichiche
lune martellanti, vuoti sibillini
*
Note orfane
vagano
tra aculei metropolitani
Percorsi tra i detriti dei senzaletto
rombano senza rumore
Simboli nei rifiuti
treni in fuga nella notte
ombre ruotano senza ragione
Un vuoto irreale vortica, lancia fiamme
e nessuna metafora
Carlo Livia
19 febbraio 2018 alle 14:52
Non credo che sia casuale porre la poesia di Mario Gabriele come emblema di massima risultanza espressiva della linea critica e ideologica rappresentata con ammirevole tenacia e coerenza in tanti anni di lavoro da Linguaglossa: una sorta di trasvalutazione dei codici e valori estetici affermati dopo il simbolismo-ermetismo, che hanno sostanzialmente riprodotto in forme sempre più epigoniche e stremate l’elegia introspettiva di Pascoli o i gesti di trasgressione più fatui e ininfluenti delle avanguardie.
Gabriele opera sulla lingua una mutazione di statuto estetico-ontologico, esaltando l’irreferenzialità del segno e decomponendo e dislocando i frammenti narrativi, come nella pittura cubista accade stravolgendo e frantumando le immagini del reale, destrutturate e deformate per mettere in luce diacronie, poliedricità, indefinizioni e mutazioni prospettiche, tensioni interiori.
Quello che manca, forse, è una tensione emotiva, un colore d’incanto, un profumo di prodigio e sacro – che da Rimbaud ai surrealisti ridefinisce il nuovo confine con la prosa – e consenta, come un richiamo nella tenebra o un sogno in un paesaggio d’esilio, di ritrovare la direzione per un’auspicata rigenerazione di istanze etiche ed estetiche, per ristabilire nuovi confini e relazioni, come avviene in Eliot e Beckett, dove la decomposizione e sconcretizzazione logico-emotiva scaturisce e si armonizza con un impasto formale dinamico, è il silenzio che pausa gli elementi sonori, il vuoto che lascia presagire il pieno, non l’inabissarsi nel deserto della definitiva assenza di voci e significati.
Il gran galà delle meraviglie
“…egli ci lasciò la sua tristezza
seduta sull’orlo del cielo come un angelo obeso”
Juan Larrea
In basso era tutto illuminato
Ma la notte restava minacciosa
L’abito della festa era bagnato di lacrime
Fra tante nuvole quale azzurro ci aspettava
Era l’amore l’ospite tanto atteso
Quanti sospiri di ragazze prima che si levi una canzone
Forse perché nessuno crede più all’eterna melodia
Entrando nel giardino bisogna recitare la preghiera
Davanti alla statua infelice ci si prende per mano
La luna restava in attesa
L’oscurità si riempiva di domande e di sorrisi
Una volta entrati la porta si richiude per sempre
Il desiderio ci rendeva leggeri come nuvole
Una macchina solitaria si lasciò sfuggire un gemito
Entrando nel salone celeste si vedeva un coccodrillo
addormentato sotto la grande acquasantiera
Un uomo che aveva rinnegato Dio sedeva in un angolo col mal di testa
Un violino muto scacciava le ombre dell’aldilà
Fra i candelabri era cominciata una battaglia di sguardi
Una timida preghiera era scivolata sul sofà
La ragazza bionda aveva racchiuso nello sguardo
un frammento di Paradiso
Tutti sospiravano vedendola passare
Alcune anime erano così sottili che si potevano vedere tutti i loro peccati
A volte scendeva il silenzio e si sentiva il pianto delle creature impossibili
rinchiuse nelle cantine
Nei corridoi ristagnava un triste odore di orfanotrofio
In fondo al profumo della danza restava una lacrima nascosta
Un ubriaco fece piangere le fanciulle dipinte sopra l’altare
Lo sguardo del signor Delirio lasciava nell’anima una ferita pallida e vacillante
Qualcuno rimasto solo finì per scomparire
La donna vestita di bianco aveva un sorriso fresco come una rosa sotto la rugiada
Lo offriva come un gioiello
In fondo allo specchio apparve la figura turchina che avevo visto in sogno
Un richiamo da un’altra eternità
O era l’ultimo angelo custode
“Potrei restare solo con lei per una notte ?
“ E’ tutto così antico ma non ricordo quando sono stata già qui “
Qualcuno mi ha sfiorato l’anima coi suoi pensieri ed è scomparso
L’uomo e la donna si sono amati segretamente
Al mattino li hanno trovati addormentati insieme
Per sempre

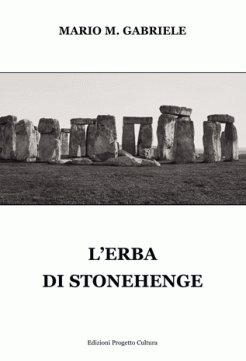
Lucio Mayoor Tosi
20 febbraio 2018
“…la voce dei vivi nell’espressione dei morti, come tanti Ghost dietro le spalle”.
In questa frase di Mario Gabriele colgo il senso tragico che accompagna le poesie e la critica poste in atto dalla nuova ontologia estetica. E’ “la Fin du monde”, che è tra l’altro anche il nome di una famosa birra. Ma di questo si parlerà più avanti, almeno spero, quando si vorrà storicizzare l’avvento della scrittura per stracci e frammenti. Intanto, con “Critica della ragione sufficiente”, Giorgio Linguaglossa pone le premesse che serviranno a nuovi poeti per smetterla di rovistare tra le rimanenze del passato. E’ un nuovo inizio, con questo libro, il “grande progetto” ha preso forma. E speriamo si tratti della punta di un iceberg. Più avanti si capirà che non c’è nulla di allegro nel tramonto culturale di quest’epoca, malgrado ci si forzi nell’alleggerire – persino Gabriele, che agisce nello sconforto in modo da renderlo pop, o la tanta ironia di chi scrive consapevole di stare nella post modernità –. Ma ontologicamente siamo morti, parliamo di morti ai morti, e tutto questo è, per me, entusiasmante. Tanto che a dovere ancora dire dell’io fa sorridere.
La scrittura critica di Giorgio Linguaglossa è letteraria, abbastanza densa di tecnicismi da poter affascinare la nascente macchina mentale e far ruotare le pupille dei poeti tra scienza e filosofia; in apparenza coi piedi per terra, in realtà proiettato nella giungla stellare dei versi-immagine.
In un post di giorni fa, Mario Gabriele scriveva : “Ogni testo ha una sua ministoria. Ma la cosa a cui non so rispondere è come abbia potuto formalizzare tutto questo con un sound quasi come un vibrafono alla Lionell Hampton” (è il pop di cui parlavo) “ Ma se la poesia non ha tutti questi riflessi, dimmi caro Tallia, c’è proprio bisogno di scrivere poesia in questo mondo in frantumazione?”.
Mauro Pierno
20 febbraio 2018
Lo dico a te
in via estemporanea
davvero senza che nulla mi fosse stato chiesto
ma la bellezza sta
nella busta della spesa,
questa poesia nascosta a malapena
è un bruco sulla credenza
nella sua mela.
A quanti dicono del tempo
rispondo che la visuale è tonda
e quando striscio
non è per compassione
è fame atavica. Resurrezione.
Un morso unico. Quotidiano
Antonio Sagredo
20 febbraio 2018
Il cielo si scurì per neri ombrelli
Dai confessionali cinguettava una condanna ambigua senz’appello,
sinistro era il calvo battito di un giudice in gramaglie nere.
Non avevo più i conforti estremi di un’anima eretica, la carne arsa
e quella fede irregolare che un celeste trono nega a malincuore.
Mi tallonava l’inutile urlo della croce e la sua smorfia stercoraria
che dal capezzale mi pianse la perdita di astragali e aliossi.
Come uno stendardo si levò la beffa simile a una profezia teatrale!
E io vidi, non so, patiboli in stiffelius e quinte martoriate come golgotha
e coi reggicalze ben in vista alati putti e sacerdoti celebrare beati,
sotto i portici del granchio, sanguinanti spine, lombi e glutei!
Ah, Dante, non avevi più urina e saliva, ma la tua lingua era ancora toscana,
cordigliera e velenosa… perfino gli uccelli scansano questa croce! – gridò.
Il cielo si scurì per neri ombrelli… tuniche codarde e orbite di livide veroniche
oltraggiarono i tramonti – chiodato dai suoi miracoli l’Incarnato pulsava
per un coito dismesso a malincuore – per un altro sesso, come un velo mestruato,
depose il divino Verbo nel postribolo – fu l’inizio della nostra croce, e la sua gloria!
I giorni che trascorsi nello specchio gelano epoche e finte apocalissi.
Promise al suo sosia e gemello le meraviglie della Terra e degli Universi
tutti, ma quel bosco fu avvelenato dalle bacche del tasso: miserie del martirio!
finzioni! resurrezione dei vivi! fede dei misteri!… compassione, per loro… ecc… ecc….


Mario M. Gabriele
19 febbraio 2018 alle 15:46
Gentile Carlo Livia,
la ringrazio della sua analisi critica relativa ai miei testi poetici. Lei è andato a fondo della sabbia verbale da cui poi ho tratto un castello con tante direzioni. Dice bene Giorgio Linguaglossa quando nell’esaminare il mio lavoro rileva il distacco da un certo tipo di poesia degli anni Settanta-Ottanta. Le dico subito che sono pervenuto a questi esiti operando con il linguaggio di un ventenne ma con l’esperienza e l’autocontrollo di una persona adulta che non ha mai rifiutato le letture di altri poeti. Ciò che manca, è la tensione emotiva ed ha ragione. Non le contesto questa emersione dalla lettura delle poesie. Ho già spiegato in un post datato, che dopo Astuccio da Cherubino, in ricordo di mio padre, non ho più articolato testi poetici segnati dall’emozione. Da qui l’uso di tecnicismi vari, con il recupero del Tempo-Soggetto, della rimemorazione delle cose, degli eventi, dello schiaffo alla vita dato, da chi non lo so! In questo senso mi rivedo nel verso di Juan Larrea da lei riportato: “Un uomo che aveva rinnegato Dio sedeva in un angolo con il mal di testa”. In un altro intervento critico, Giorgio Linguaglossa si è chiesto da dove mai venga questo modo di fare poesia. Qui entrano in gioco molti fattori plurali e dis-greganti, ma anche la voce dei vivi nell’espressione dei morti, come tanti Ghost dietro le spalle. Non mi dilungo per non annoiarla, ma quello che ho scritto qui è il guscio di una noce che contiene il gheriglio della vita. Grazie.
Salvatore Martino
19 febbraio 2018 alle 19:56
Il tempo custodisce affreschi,
salva le tue ultime canoe.
Riparte l’archivio degli anni,
non uno che si metta al riparo
dall’onda dello tsunami.
Pure qualche strofa risale dai fondali.
La città si rannicchia nella neve.
Di cosa hai paura Ramous?
Padre Alvarez chiude il sermone
disegnando il TAU dal Libro di Ezechiele.
Non so perché i versi di Gabriele così apparentemente calati nell’oggettività e, come dice Livia, mancanti di tensione emotiva riescano a penetrarmi al profondo, a generare un pathos nel mio essere corpo e anima, Certo rileggendo i versi sopra riportati forse la risposta mi arriva. Spesso riesce il poeta a introdurre baluginanti versi,che corrodono la realtà, trasfigurandola in sogno, in avventura, e i suoi personaggi , fantasmi in delirio, assumono una compattezza, una vitalità, che supera ogni nominalismo.
Non ho gli strumenti critici per analizzare il suo stile che è suo e di nessun altro, con il ricordo masticato di Eliot e di un confessatissimo Becket, più il primo direi, con quelle ambientazioni familiari e quotidiane che rimandano all’assoluto. Il dispiegamento culturale che in altri potrebbe risultare stucchevole in Gabriele è un altro veicolo di coinvolgimento, e nonostante tutto possa apparire costruzione cerebrale , misteriosamente il dettato poetico si slarga in un fiume che avvolge il lettore e suo malgrado lo spinge a focalizzare i tratti più decisamente poetici ,che corrono nelle trame di un basso profilo quasi volutamente prosastico. Così incontriamo versi memorabile che si incidono. «In un angolo giocatori d’azzardo/ puntavano sull’eclisse lunare». Perdonami carissimo Mario se non sono capace di un discorso critico, getto queste mie parole, così come mi vengono suggerite , da una lettura a voce alta, che mi evidenzia il ritmo sonoro di questa frammentazione circolare. E il mosaico alla fine forse davvero ricompone la faccia di te poeta, di te uomo.
Mario M. Gabriele
19 febbraio 2018 alle 21:30
Caro Martino,
mi chiedo come si possa scrivere poesia alla nostra età? Quali sono i punti di raccordo? Che cosa ci allontana da questo mondo di sfrenato Capitalismo, senza trascurare le azioni del Male? Siamo, forse, come dice Alfredo de Palchi ancora degli antropomorfi? La mancata tensione emotiva, fatta rilevare da Carlo Livia, viene da me sostituita con l’uso delle frammentazioni del tempo, attraverso le tecniche del laboratorio linguistico, per far riaffiorare il ricordo, che per me suscita emozioni, e credo anche per chi vi ricorra all’imbrunire della sera, dove l’archivio degli anni non ci salva dallo tsunami,ossia dall’oblio. Ecco il motivo perché scriviamo e che in un certo senso cerco di rispondere alla prima domanda sopra riportata. Ringraziandoti sinceramente del tuo commento, ti invio cordiali saluti.
Antonio Sagredo
20 febbraio 2018 alle 0:23
Sono passati sei minuti del nuovo giorno e questa antologia linguaglossiana segna l’inizio di una critica sufficiente a illuminare la condizione della poesia italiana della fine del secolo scorso e dell’inizio del nuovo secolo. Ho dato dapprima uno scorrimento veloce per avere una idea strutturale e compositiva di questa opera che resterà negli annali della storiografia italiana.
Linguaglossa ha il suo destino nel significato del suo cognome che viene continuamente onorato.
Mi ha sorpreso il coraggio e la sfrontatezza delle sue dichiarazioni: ambedue “sufficienti” per stabilire le posizioni dei poeti: perizia e acume si avvicendano.
Coraggio, molto e tanto, che testimonia il non aver paura e timore di sbagliare il giudizio. Questo lo può fare soltanto un non accademico che la sa lunga come deve essere trattata la Poesia, e non col timore di errare che pregiudicherebbe la carriera…accademica. Libero e sciolto dal vincolo di non appartenere a nessuna accademia (o se volete cricca da quattro soldi) egli svolge e segna una operazione critica puntigliosa e precisa col bisturi delle sue conoscenze. Non ha bisogna di uno stile singolare: va diritto allo scopo e sentenzia.
Scopritore di grandi talenti, emarginati dai poteri editoriali e delle varie critiche ufficiali, li beffeggia mostrando loro chi ha merito e chi ha demerito senza attenuanti, senza dubbi, e va il suo battello diritto, o a destra o a manca come richiede appunto il puntuale artificio della sua arte critica.
E certo che dà fastidio il Linguaglossa a tanti luminari critici incollati alle loro schifose poltrone con la loro stessa m…a!
Domani, se ne ho voglia, continuo e se mi va farò anche i nomi!
Mauro Pierno
20 febbraio 2018 alle 7:42
[diversione da una poesia di Donatella Costantina Giancaspero]
un timbro un verso.
una tazzina di caffè
lungo, grazie.
un discorso diversivo in un solo verso.
in direzione del bar, forse.
ci saranno cambiamenti nella nostra vita?
la mia anima è una barca
senza mare né sponde.
rispondere non serve. l’input innescato.
la rivoluzione in un sol giorno,
com’è cambiata la nostra vita dopo il
1996? si sporgono alla finestra lievi bandiere.
sventolano pure.
un vento irriverente non scopre il logo.
la poesia ha un sol giorno.
l’enfasi del tempo. l’antologia odierna.
