Anna Ventura La vergine di Norimberga, con Commento di Giorgio Linguaglossa

Anna Ventura è nata a Roma, da genitori abruzzesi. Laureata in lettere classiche a Firenze, agli studi di filologia classica, mai abbandonati, ha successivamente affiancato un’attività di critica letteraria e di scrittura creativa. Ha pubblicato raccolte di poesie, volumi di racconti, due romanzi, libri di saggistica. Collabora a riviste specializzate ,a quotidiani, a pubblicazioni on line. Ha curato tre antologie di poeti contemporanei e la sezione “La poesia in Abruzzo” nel volume Vertenza Sud di Daniele Giancane (Besa, Lecce, 2002). È stata insignita del premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha tradotto il De Reditu di Claudio Rutilio Namaziano e alcuni inni di Ilario di Poitiers per il volume Poeti latini tradotti da scrittori italiani, a cura di Vincenzo Guarracino (Bompiani,1993). Dirige la collana di poesia “Flores”per la Tabula Fati di Chieti.
Suoi diari, inseriti nella Lista d’Onore del Premio bandito dall’Archivio nel 1996 e in quello del 2009, sono depositati presso l’Archivio Nazionale del Diario di Pieve Santo Stefano di Arezzo.
È presente in siti web italiani e stranieri; sue opere sono state tradotte in francese, inglese, tedesco, portoghese e rumeno pubblicate in Italia e all’estero in antologie e riviste. È presente nei volumi: AA.VV. Cinquanta poesie tradotte da Paul Courget, Tabula Fati, Chieti, 2003; AA.VV. e El jardin,traduzione di Carlos Vitale, Emboscall, Barcellona, 2004. Nel 2014 per EdiLet di Roma esce la Antologia Tu quoque (Poesie 1978-2013). Dieci sue poesie sono presenti nella Antologia di poesia Come è finita la guerra di Troia non ricordo a cura di Giorgio Linguaglossa (Roma, Progetto Cultura, 2016)
La vergine di Norimberga*
La Vergine di Norimberga
non avrebbe voluto straziare
il bel giovane che già stava lì, per terra,
in catene,
ad aspettare la morte. Ma lei
era la Vergine di Norimberga
e doveva ubbidire al suo compito.
Perciò quando immaginò il sangue dell’uomo
scorrere lungo le sue membra ferrate,
immaginò il pallore del suo volto,
gli occhi già rovesciati alla morte,
invocò su se stessa
l’aiuto degli dei, e delle dee,
specialmente di queste ultime:
perché, essendo donne,
avrebbero meglio compresa la sua pena. Ma quelle
avevano altro da pensare.
Fu Cupido, invece,
a raccogliere il pianto della Vergine,
lui così attento
a qualunque sospiro d’amore.
Poiché era un dio,
poteva anche fare un miracolo: fece in modo
cha la Vergine si coprisse di fiori: tanti fiori
da rivestire le punte delle lance.
Il che, tuttavia,
non ottenne altro che allungare la pena.
Alla fine, fiori e sangue si mescolarono
sulla terra bruna: un intrigo
non più complicato
di tanti altri.
* (notizie storiche sulla Vergine di Norimberga)
La Vergine di Norimberga, chiamata anche vergine di ferro, è una macchina di tortura inventata nel XVIII secolo ed erroneamente ritenuta medioevale, a causa di una storia raccontata da Johann Philipp Siebenkees che sosteneva fosse stata usata per la prima volta nel 1515 a Norimberga. Non esistono prove che tali macchine siano state inventate nel Medioevo né utilizzate per scopi di tortura, nonostante la loro massiccia presenza nella cultura di massa. Sono state invece assemblate nel Settecento da diversi manufatti trovati nei musei, creando così oggetti spettacolari da esibire a scopi commerciali.
La macchina consiste in una specie di armadio metallico a misura d’uomo e di forma vagamente femminile, più o meno grande a seconda dei casi, pieno di lunghi aculei che penetrano nella carne senza ledere organi vitali.
Il condannato ipoteticamente veniva fatto entrare in questo “sarcofago” e, chiudendo le ante, veniva trafitto dai suddetti aculei in ogni zona del corpo, morendo lentamente tra atroci dolori. In realtà simile strumento non è stato usato almeno fino al XX secolo (un’apparecchiatura di tale tipo è stata trovata durante un reportage televisivo a casa di Udai Hussein, il figlio maggiore dell’ex dittatore iracheno Saddam Hussein).

Commento di Giorgio Linguaglossa
Questa è una poesia recente di Anna Ventura, se ricordo bene, del 2015. L’andamento colloquiale e il tono di ironico distacco sono i tipici procedimenti impiegati dalla poetessa nel corso di tutta la sua produzione a far luogo da Brillanti di bottiglia del 1972. Una poesia in sottotraccia, understatement, dove il «detto» sembra corrispondere al «voler dire»; c’è invece un interdetto che apre una divaricazione tra il «detto» e il «dire», un po’ alla maniera della Szymborska, del suo minimalismo metafisico. Ebbene, Anna Ventura nel corso del suo tragitto poetico più che quarantennale ha sempre mantenuto ferma la direzione di ricerca: una dizione essenziale, un lessico sobrio, un verso libero, spezzato in modo non convenzionale, tematiche le più varie, che vanno dal quotidiano al metafisico del quotidiano, impiego del traslato, impiego di una metafora direi implicita al discorso poetico senza impiego di retorismi eccentrici e senza dispiegamenti di eccessi linguistici e stilistici. Oserei dire che Anna Ventura in tutti questi anni ha pagato lo scotto della scelta di un tipo di poesia che non consentiva digressioni nel privato o cedimenti alla moda degli oggetti esibiti o cedimenti alle mode poetiche; così ha pagato in tutti questi anni il dazio per una poesia che non è mai scesa a compromessi con le mode della vulgata maggioritaria ed ha anticipato in tempi non sospetti gli esiti e gli elementi di quel tipo di poesia che noi oggi chiamiamo la «nuova ontologia estetica». Oggi noi sappiamo che una riforma linguistica della poesia italiana comporta anche una rottura del modello maggioritario entro il quale è stata edificata negli ultimi decenni un certo tipo di poesia dotata di «immediata riconoscibilità». È un dato di fatto che qualsiasi operazione di «rottura» determini necessariamente una solitudine stilistica e linguistica a chi si avventuri in lidi così perigliosi e fitti di naufragi. Ma, giunti allo stadio zero di «riconoscibilità» della scrittura poetica di moda oggi, una rottura è non solo auspicabile ma necessaria.
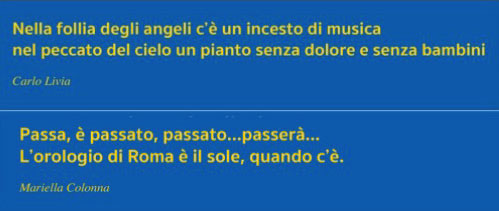
Scrive Gianni Vattimo:
«si può dire probabilmente che l’esperienza post-moderna (e cioè, heideggerianamente, post-metafisica) della verità è un’esperienza estetica e retorica (…) riconoscere nell’esperienza estetica il modello dell’esperienza della verità significa anche accettare che questa ha a che fare con qualcosa di più che il puro e semplice senso comune, con dei “grumi” di senso più intensi dai quali soltanto può partire un discorso che non si limiti a duplicare l’esistente ma ritenga anche di poterlo criticare».1
Mi sembra chiaro che qui la «vergine di Norimberga» assume nella psiche la posizione e il ruolo del «fantasma», cioè di quell'oggetto di desiderio e di ripulsa, se non di orrore, che coglie colui che sogna ad occhi aperti o chiusi. Il «fantasma» è tale in quanto esercita un ruolo fantasmatico e simbolico, ma anche un sottile ed equivoco fascino, anche erotico, sul quale non è possibile intervenire se non con la rimozione e la cancellazione della «traccia». L'esperienza del «fantasma» è quindi, con il linguaggio di Vattimo, una vera e propria esperienza estetica e retorica.
1 G. Vattimo, La fine della modernità,Milano, Garzanti, 1985, p. 114 .
