
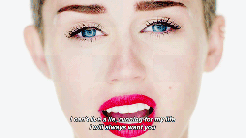

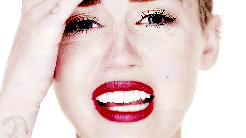
Si è detto che la poesia è anche, immancabilmente, esperienza del limite, limite che è già inizio dell’estraneità, e quindi illeggibile, insuperabile, non c’è parola, intuizione, simbolo o immaginazione capaci di farlo nostro o di ridurlo. È l’equivalente del limite ultimo della vita: in questo senso la poesia è vita, e non limitazione di essa.
Vorrei che fossero altro questi sedicenti poeti, giovanissimi e giovani, che in qualche occasione pubblica mi guardano storto, loro che non hanno letto niente dei libri che ho scritto, e mi salutano appena, forse per fare contento il loro tutore che non mi ama, o forse perché io non sono mai riuscito a elogiare i loro versi.
La poesia è finita. Prima era essere che aveva le vertigini di fronte ai suoi limiti, era essere e non essere. Oggi è un intruglio bastardo di essere e superessere.
Diranno in coro: sarà finita la tua poesia, ma la nostra no!
Ma non è questione di mia o vostra. Insisto: forse non vi accorgete che la poesia non trova più ascolto. Non c’è più spazio per la poesia. Il troppo pieno, la parola piena, la comunicazione continua hanno sepolto i migliori poeti del secondo Novecento: non si leggono più, non hanno più la considerazione che prima, trenta anni fa, si dava loro. Tra vent’anni nessuno saprà più che erano Saba, Erba, Giudici, Luzi, Zanzotto, Sereni, Raboni, Porta… Solo qualche solitario ricercatore universitario… ma saranno pochissimi studiosi. La poesia sarà irrilevante, sarà scomparsa.
Si è detto: la quantità ha spento la qualità. La quantità di internet, della ipercomunicazione pubblicitaria, dei supermercati, dei centri commerciali e di ogni tipo di esposizione e di vendita. Uno dei tanti effetti di distruzione provocata dall’alluvione continua della quantità è la scomparsa (o quasi) di quella sensibilità che faceva distinguere la poesia dalle composizioni in versi (non poesia). Chiediamoci: come faceva Raboni (tanto per fare il migliore esempio) a scegliere i testi da pubblicare (nelle collane da lui curate) o far pubblicare? Si affidava a quella sensibilità ricca di grande talento, di esperienza finissima di lettore, e di una percezione che riassume in sé smisurata cultura e mirabile intelletto e fa riconoscere l’oro tra tanto similoro.
La poesia non può essere affabile, accattivante, popolare, attraente l’immediata emotività: perché la scrittura che ha queste caratteristiche è cattivo giornalismo in versi.
Questo libretto non sarà bene accolto dai poeti giovani e meno giovani. Guai a toccare il narcisismo dei poeti, e di coloro che li limitano scrivendo versi! […]
Beati coloro che credono che la poesia oggi attraversi un periodo di rigoglio e di espansione, di vigore e di qualità, una rinascita. Beati i giornalisti che scrivono, non sapendo cosa scrivere, che la poesia va. beati i poeti che oggi sono i primi perché domani saranno gli ultimi. […]


Il matrimonio dell’invadenza del linguaggio mediatico, superficiale e utilitaristico, con l’opportunismo delle relazioni personali (scambio di favori, protezione come segno di potere, bisogno di seguaci) annienta la poesia.
Prima i poeti che mostravano notevoli qualità riconosciute erano cinque o sei per generazione. Adesso sono cinquanta, tutti meritevoli della stessa attenzione. Altro che livellamento, altro che appiattimento! Non si vuole più distinguere tra poesia e versificazione. È il sottobosco (così lo si chiamava) che si è costruito fusti e rami alti e spaziosi!
Qualcuno ha creduto che l’abbraccio con la dimensione dello spettacolo o con il mondo della rete non fosse mortale per la poesia. Si è sbagliato. Il principio della selezione guida poesia e poeti, principio che è negato da internet e molto spesso anche dallo spettacolo.
La parola di internet è parola abusata. Internet è il luogo dell’abuso della parola. Per essere ancora più chiari: parola violentata, stuprata.
Ora si parla di «contaminazione» possibile tra poesia e canzoni di musica leggera. ma per carità! Come si fa a discutere di una sciocchezza simile? Le due realtà sono una l’opposto dell’altra. la poesia pone questioni grandi sull’esistenza, sul nostro essere al mondo, sui limiti del nostro percepire e sentire, e dunque si rivolge all’irrappresentabile e davanti a esso di ferma.
Le canzoni sono splendidi conforti alle nostre emozioni tristi e nostalgiche e al tempo stesso sono una spinta alla socializzazione.
Rimane a più osservatori oscuro e inspiegabile il risentimento con cui Berardinelli, a partire dal 1981, ha tante volte parlato della poesia italiana del secondo Novecento. Amarezza, asprezza, delusione? Chissà! Eppure anche lui, per un breve periodo, alla fine degli anni Settanta, ha provato a scrivere poesia.
La poesia è come una tessitura finissima e traforata (penso a un merletto, a un pizzo, a una trina) nella quale non è il pieno (i fili) che sostiene i vuoti (i fiori), ma sono i vuoti che sostengono i fili.
Con il proliferare di scriventi versi tutti bravi, può venire a un poeta la tentazione di guidarne un manipolo, di avere un seguito di ammiratori aspiranti a collocazioni pubbliche più alte, visto che quasi sempre non basta loro l’autodesignazione di poeta. Ma questa corrispondenza costerebbe cara al poeta: diventerebbe un principe, o un re, del sottobosco.
Il critico della poesia deve ogni volta coniugare il proprio pensiero con il testo in questione, matrimonio di volta in volta difficile nelle sue particolarità non generalizzabili, e invece non deve ricorrere per tutti i testi alle stesse definizioni, alle stesse formule.
Allora ricapitoliamo le condizioni sfavorevoli alla poesia di oggi: la prima è la pretesa di numerosi giovani (e di alcuni meno giovani) di diventare poeta per grazia sovrannaturale, per miracolo.
Invece bisogna leggere tanta poesia, finché entri nel sangue. e si tratta di leggere le opere dei poeti.
L’imitazione è assolutamente da evitare, quando è consapevole e furba. Quando è inconsapevole (e può succedere spesso ai giovani scrittori anche promettenti), c’è da augurarsi che ci se ne accorga presto.
C’è poi un altro pericolo, l’invadenza e la suggestione dei linguaggi mediatici e pubblicitari. Al tempo stesso c’è l’ambizione di raggiungere i risultati senza abbandonare la pigrizia, col minimo sforzo, con l’autopromozione e l’autodefinizione di «poeta».
Altra condizione sfavorevole per la poesia dei nostri giorni è la critica militante: sempre più occupata dai libri dei narratori seri o improvvisati, sempre meno interessata alla poesia. del resto la logica mercantile si impone su case editrici e giornali, per cui si privilegia ciò che offre più lettori e più vendite.
Ma il problema della critica è l’incontro con la poesia: si dovrebbe illuminare la specificità di ogni testo poetico e invece, come si è detto, è sempre più frequente (salvo qualche bella eccezione) l’uso delle stesse definizioni e frasi, ormai formule di repertorio, per tutti i libri recensiti.
Altra condizione sfavorevole alla poesia riguarda la pubblicazione (l’editoria è entrata in una strettoia). L’editore gradisce e valorizza il libro di narrativa o di poesia che venda molto (è raro che sia la poesia), che abbia un pubblico di acquirenti e lettori numeroso: in tal caso il libro diventa alimento economico per la casa editrice, reddito. Il suo autore sarà trattato con particolare gentilezza e cura. inconsapevolmente anche le persone più limpide e acute, più colte e sensibili subiscono l’effetto di valore del libro che vende molto.
[…]


Ai miei tempi le cose andavano diversamente: nel 1981 e nel 1990 i miei libri di poesia (Mondadori) vinsero due bei premi, e l’editore fece uscire una pubblicità di notevoli dimensioni su “la repubblica”, riproducendovi la copertina del libro (il secondo fu anche ristampato e fascettato col nome del premio), libri che certamente non vendettero più di 1500 o 2000 copie.
Aspirare a un numero elevato di lettori di poesia è un errore…
Esiste la «nuova» poesia, la poesia del Duemila? Non è mai esistita la «nuova» poesia: la poesia è sempre stata la stessa, se è sempre stato indefinibile il suo nucleo essenziale. È pur vero che ogni volta la poesia è nata dalla tradizione… per poi cercare un’originalità di forme e di espressioni. E questa poesia del Duemila, giovane o meno giovane, ha ignorato la tradizione, ha mancato la nascita, non è nata. Si è riempita di parole, frasi, idiomi, suggestioni circolante e corrive, pubblicitarie ed efficaci, mutuate da ogni emittente. Questa poesia non è poesia.
Oggi, nello scrivere versi, si tenta un’operazione analoga a quella delle installazioni nell’arte: un linguaggio interessante, suggestivo, attraente, ben organizzato con belle apparenze, artefatto.
Cari giovani poeti,
vi mando un caro saluto e una raccomandazione: quella di non adirarvi e non angosciarvi se qualcuno critica le vostre poesie e le considera solo scritture in versi. Pur nella relatività di ogni lettura, le critiche possono essere necessarie e salutari proprio per passare dai versi alla poesia.
E noi anziani dobbiamo scusarci con voi e riconoscere che siamo stati colpevoli di alcune bugie per cosiddetta bontà o viltà.
Chi ama la poesia, prima di scriverla, ne leggerà tanta: prima di amare la propria, amerà quella scritta dai poeti che, nei secoli, hanno fatto conoscere la loro opera. Chi scrive versi senza aver prima smisuratamente amato la poesia è un povero naufrago nel mare del narcisismo.
Il miglior consiglio che si può dare a chi si avvicina alla scrittura della poesia… è quello di evitare gli insegnamenti. e quindi: non frequentare scuole di scrittura o di poesia.
Uno che sa tutto, saccente, non sarà un poeta. Uno che pensa di potere tutto, arrogante, e si compiace della propria abilità non sarà un poeta. La misura di sé non è un rispecchiamento compiaciuto («quanto sono bravo»). Misura di sé è qualcosa che non ha niente a che fare con le tentazioni dell’infinito: è cosa finita, è percezione netta, nuda e cruda, dei limiti (della misura), dei limiti superabili e poi, necessariamente, anche di quelli insuperabili.
Se tutte le frasi pensate, se tutti i pensieri cominciano o contengono il pronome “io”, e se l’interesse personale occupa tutto lo spazio dell’immaginazione e dell’emozione, allora in questo caso siamo lontani dalla poesia… se l’io invade e domina anche lo spazio delle relazioni affettive e dei pensieri rivolti all’umanità e alla società… allora con questo io sovrano sarà impossibile arrivare a scrivere poesia.
( La vita presenta a volte strane coincidenze. e sono davvero strane coincidenze – non c’è malizia. Per esempio, una che mi è capitata: finché si è pensato che potessi avere un qualche potere editoriale o recensorio, il telefono squillava ogni giorno con voci amiche e gentili. Quando si è capito che non ho nessun potere, nessuno più mi ha chiamato né è venuto a farmi visita. Così come un’altra casualità: se ad un giornale collabora un recensore che ha un cattivo rapporto personale con un poeta, possono verificarsi casuali effetti di allineamento degli altri recensori, e va a finire che su quel foglio nessuno scriverà di quel poeta. Ma allora, tutto il mondo è paese?)


Risposta di Alfonso Berardinelli, da Poesia non poesia, Einaudi, 2008 pp. 4 e segg.
Le regole che governano la produzione giornalistica e i media sono ormai piú impegnative di quelle che governano i testi poetici. A un vero poeta una sfida del genere non dovrebbe dispiacere.
Io non credo nella poesia. Credo soltanto in quelle poesie che mi fanno credere in loro. Se convince il lettore, la poesia non ha bisogno di essere difesa. Se non lo convince perché difenderla?
Credo che oggi il piú insidioso e temibile nemico della poesia sia la poesia stessa, o meglio la sua idea, il suo mito, la sua nobiltà tradizionale: un valore che appare tuttora garantito di per sé come eccellente.
Dopo il 1975, a partire da un libro inchiesta che pubblicai con Franco Cordelli, Il pubblico della poesia, il recupero e la “riappropriazione”della poesia da parte di tutti (il Movimento) comportarono l’oblio di circa il precedente e più che secolare dispiegamento di coscienza autocritica che aveva caratterizzato la poesia moderna. Un’autocritica produttiva se aveva prodotto Schiller, Leopardi, Baudelaire, Eliot, Majakovskij, Montale, Ungaretti, Brecht, i surrealisti e innumerevoli altri classici della modernità.
A metà degli anni Settanta diventò chiaro che si stava ricominciando da un grado zero dell’autocoscienza storica. Cosa che in sé poteva anche significare un nuovo e particolare tipo di interruzione della continuità rispetto al passato prossimo. Niente più né impegno né avanguardia. Cioè niente rapporto dialettico fra poesia e storia, fra evoluzione o mutamento delle forme letterarie e processo storico, comunque lo si intendesse. Il potenziale autocritico precedente, in Italia sintetizzato da poeti ipercritici come Fortini e Sanguineti, veniva disinnescato perché il fardello dei presupposti di autocoscienza storica era diventato troppo pesante per i nuovi poeti. L’autonomia, l’autarchia creativa veniva ora resa possibile dall’eliminazione di quel particolare negativismo ascetico trasmesso dall’Estetica del Silenzio (come la definì Susan Sontag) e dalle ipotesi sulla fine imminente dell’Arte.
Le poesie di Amelia Rosselli, Fortini, Zanzotto, Sanguineti sembravano scritte nel giorno che precede una rivoluzione capace di rendere superflua la creatività specificamente e tradizionalmente artistica. Non a caso nella prefazione al Pubblico della poesia, evocando ironicamente il pathos novecentesco del rapporto poesia-rivoluzione, scrivevo che un poemetto di Gregorio Scalise, un po’ come le poesie di Francis Ponge, sembrava scritto dopo una rivoluzione vittoriosa. Dato che non c’era stata, propriamente parlando, nessuna rivoluzione, quel dopo significava nient’altro che l’idea di rivoluzione aveva cominciato improvvisamente ad appartenere al passato. La poesia era quindi libera di riprodursi in regime di innocenza storica e politica. Non doveva rispondere a nessun tribunale.
La stessa critica letteraria era disarmata e priva di legittimazione “militante”, fondata in precedenza, da circa due secoli, sul conflitto fra tradizione e innovazione, fra rivoluzione e restaurazione, fra progressismo e conservatorismo. Perciò: scrivete pure poesia senza pensarci troppo! Nessuno potrà più giudicarvi in nome di presunte istanze superiori (cioè storico-politiche) né teoriche né pratiche!
Intorno alla metà degli anni Settanta, la poesia di oggi non era più la poesia di ieri. E la poesia di oggi era quella che scrivevano e avrebbero scritto le generazioni nate dopo il 1935. Il salto, il distacco (volendo fare solo qualche nome) è quello che avviene fra Pagliarani e Zeichen, fra Raboni e Cucchi, fra Andrea Zanzotto e Patrizia Cavalli. Cosa era successo in quell’intervallo? Si possono fare diverse ipotesi. Ne faccio due, intanto. La prima è che l’idea ossessiva dell’interruzione della continuità e del balzo da una sponda all’altra della Storia, senza aver prodotto l’avvento di una società liberata e senza classi, aveva prodotto invece la situazione postmoderna – che in verità ha caratterizzato in forme implicite tutto il periodo che segue il 1945 e in forme esplicite il cosiddetto post-Sessantotto.
Eravamo, nel 1975, alle forme esplicite. Il fardello della modernità veniva deposto. La croce dell’autocritica dell’arte veniva abbandonata. Si cominciava, si ricominciava a scrivere in un diverso tipo di presente, un presente senza passato. O meglio: in un presente che non riconosceva più nessun privilegio al passato prossimo, moderno e novecentesco, ma poteva invece compiere vertiginosi, remunerativi o del tutto gratuiti salti all’indietro, in diversi passati remoti. Si poteva scrivere poesia pensando a Lucrezio, a Catullo, a Marziale, a Guido Cavalcanti, e John Donne, a Metastasio, a Shelley. Nel giro di pochi anni la stessa Tradizione del Nuovo, cioè tutta la poesia moderna era visitata non più come un tempio in cui compiere atti di fede, di iniziazione e di sacrificio, ma come un museo dentro cui aggirarsi, un po’ oziosamente, in cerca di evasioni o di modelli da imitare senza impegno e senza neppure crederci troppo. Baudelaire poteva essere riletto come Villon, Whitman come Bukovski o Carver. Tutti ugualmente attuali e archeologici, viventi e sepolti nello stesso tempo. L’eterno ieri (che secondo Max Weber fonda la Tradizione), ormai senza più nessuna autorità e al servizio del presente, si estendeva da Saffo e Li Po fino a Elsa Morante, Penna e Caproni.


Inebriante libertà! Tutto era possibile: dalle centurie di quartine di Patrizia Valduga, dagli endecasillabi e settenari di Bianca Tarozzi, di Patrizia Cavalli e Riccardo Held, fino ai versi liberi (sempre troppo liberi) e alla prosa poetica senza «a capo» che più recentemente si sta impadronendo dei libri di poesia e si alterna agli eccessi di metricismo.
Circa quindici anni fa, quello che allora era un giovane critico, Mario Barenghi, scrisse su “Linea d’ombra” un intervento sorprendente che non riesco a dimenticare. Proprio mentre si diffondevano le più convinte e in apparenza inoppugnabili certezze sulla creatività poetica ritrovata, ecco che Barenghi diceva una verità altrettanto e ancora più inoppugnabile. Si chiedeva come mai, alla fine di ogni anno, quando facciamo i nostri personali bilanci di lettori e ci sentiamo in debito per non aver letto quel romanzo o quel saggio, perché fra i libri che sentiamo di aver dovuto leggere non ci sono mai, ma proprio mai, i libri di poesia contemporanea. Chi si sente più in difetto o in colpa per non aver neppure preso in considerazione i trenta o i sessanta volumetti poetici pubblicati nell’ultimo anno? Nessuno si rammarica più, diceva Barenghi, di queste lacune e inadempienze. Neppure i critici, gli studiosi, i docenti di letteratura contemporanea.
Dopo molti anni da quella scoperta di Barenghi le cose non sono cambiate. Escono diverse antologie. Ma bisogna proprio essersi programmati come critici di poesia italiana attuale per leggere queste antologie sempre più pletoriche, per analizzarne i criteri di selezione e valutare le scelte critiche dei curatori. Si fa presto. Basta un’occhiata ai poeti inclusi per controllare quanti e quali sono i poeti esclusi ( si procede per decine, non per unità). Si scorre l’introduzione. Ma chi legge o rilegge davvero le poesie antologizzate? […] Il vincolo con il passato si è allentato fino a diventare inafferrabile per tutta la letteratura, non solo per la poesia. Ma almeno la narrativa e la saggistica hanno il loro pubblico. Il pubblico della poesia resta un fantasma, un pubblico di non lettori, una virtualità che sembra condannata a rimanere tale.
Come si può parlare criticamente, usando il linguaggio della critica letteraria, voglio dire, con il suo carico di cognizioni storiche e tecniche, occupandosi di tanti nuovi poeti? Me lo chiedo da tre decenni. Ma ogni volta è come se fosse la prima volta. La produttività poetica dilaga. Negli ultimi due o tre anni devo essermi distratto (me ne accorgo ora) perché apprendo che sono nate nuove scuole, nuove tendenze, di tonalità prevalentemente sadico-ilare o depresso-sadica. Ci sono in giro e in piena attività almeno venti o trenta poeti di cui so ben poco. Provo a leggere, a informarmi. Ma noto che la cosa più difficile è proprio questa. Già dire leggere è un eufemismo, perché leggere la maggior parte di queste poesie è difficile. Non meno difficile è quindi informarsi perché dai testi antologizzati si ricava poco, non bastano a farsi un’idea degli autori, mentre i libri interi sono ridondanti e fuori misura, perché dopo le prime pagine si sa già tutto.
Leggere i poeti italiani contemporanei è quasi sempre esasperante. non si capisce perché dopo quella frase c’è quell’altra, non si capisce perché il testo finisce a quel punto, non prima, non dopo. È veramente strano che con tante scuole di scrittura creativa, nessuno sia riuscito, in questi ultimi dieci anni, a insegnare il minimo di tecnica utile.
…Il titolo di un libro di Alessandro Carrera: I poeti sono impossibili… il libro possiede un’importante qualità letteraria: la capacità davvero molto poetica di far vedere che oggi come ieri la poesia la fanno i poeti e che quindi finisce inevitabilmente per somigliare a loro.
All’inizio del quarto capitolo, intitolato Siamo tutti grandissimi poeti, Carrera ci ricorda una cosa: Robert Musil «osservò che la decadenza della modernità era iniziata il giorno in cui nella cronaca sportiva di un quotidiano viennese si potè leggere che un certo cavallo, gran vincitore di corse, era geniale».
Orazio lamentava che i poeti fossero innumerevoli. Quevedo scriveva che «Dio aveva mandato un’epidemia di poeti in Spagna per punirci dei nostri peccati; due secoli dopo, Pietro Giordani, si lamentava con Leopardi che ormai chiunque sapesse leggere e scrivere si riteneva in grado di impugnare carta e penna e gettar giù versi a profusione. Osip Mandel’stam constatava con scoramento l’esistenza di un miserabile esercito di poeti che aveva invaso la Mosca rivoluzionaria». Montale scrisse che «se Guglielmo Giannini, invece di fondare il movimento dell’Uomo qualunque, con obbligo dello stato di stampare a proprie spese i versi di ogni cittadino, avrebbe mandato almeno un centinaio di deputati in Parlamento»
COMMENTI:
Giorgio Linguaglossa
In onore di Alfredo de Palchi, pubblico qui questa mia invettiva:
LA VOSTRA GENERAZIONE SFORTUNATA
à la maniére di Trasumanar e organizzar (1971)
Cara generazione sfortunata dei poetini di vent’anni,
di trent’anni, di quarant’anni, di cinquant’anni, di sessant’anni…
Vi scrivo questa lettera.
Guardatevi intorno:
dove vi sta portando questo treno di feroce mediocrità,
di feroce ambiguità, di feroce ipocrisia?
Guardatevi allo specchio: siete tutti invecchiati, imbruttiti, malvissuti
vi credevate giovani e invece siete diventati vecchi, conformisti,
leghisti, sfigati, banali, balneari…
Che tristezza vedo nelle vostre facce,
che ambiguità, che feroce vanità, che feroce mediocrità:
CL, PD, PDL 5Stelle, Casa Pound, destra, sinistra, pseudo destra, pseudo sinistra,
immigrati, emigrati, referenziati con laurea, senza laurea,
con diplomi raccattati, rattoppati, infilati nel Sole 24 ore,
settore cultura, nella Stampa,
a scrivere le schedine editoriali degli amici e degli amici degli amici,
nelle case editrici che non contano più nulla…
Guardatevi allo specchio: siete sordidi, stolidi, non ve ne accorgete?
Guardatevi allo specchio! Siete dei Buffoni, dei malmostosi!
Che tristezza questa italia defraudata,
derubata, ex cattocomunista, leghista, cinquestellista, renzista…
Voi, Voi, Voi soltanto siete responsabili
della vostra inaffondabile mediocrità,
e non chiamate in causa la circostanza della mediocrità altrui,
della medietà generalizzata,
la responsabilità è personale ai sensi del codice penale
e del codice civile…
Voi, unicamente Voi siete i responsabili
della vostra insipienza e goffaggine intellettuale…
Che tristezza: non avete niente da dire, niente da fare,
disoccupati dello spirito e disoccupati
della stagnazione universale permanente che vi ha ridotto
a mostri di banalità con i vostri pensierini
paludosi e vanitosi alla ricerca di un grammo di visibilità
nei network, nei social, con il vostro sito di leccaculi e di paraculi,
svenduti senza compratori…
Che tristezza vedervi tutti abbottonati, educati e impresentabili
in fila dinanzi agli uffici stampa degli editori
a maggior diffusione nazionale!
Che tristezza nazionale!
Caro Pier Paolo, quel giorno di novembre del 1975
io ero a Roma, scendevo alla fermata del bus 36
(catacombe di Sant’Agnese) per andare a via Lanciani
al negozio di scarpe di mio padre quando seppi del tuo assassinio…
Capii allora che un mondo si era definitivamente chiuso,
che sarebbero arrivati i corvi e i leccapiedi
e i leccaculo, i mediocri, i portaborse…
Lo capii allora scendendo dal bus la mattina,
erano le ore 8 del mattino o giù di lì,
e capii che era finita per la mia generazione e per quelle a venire…
Lo ricordo ancora adesso. È un lampo di ricordo.
(scritta in diretta, su L’Ombra delle Parole)
Donatella Costantina Giancaspero
Alla morente poesia, poi, Facebook ha dato il colpo di grazia; Facebook, insieme a tutte quelle pseudo case editrici mangiasoldi, che danno vita a un mercato parallelo di poeti inesistenti; insieme a tutti quei concorsini e concorsucoli, che risucchiano i partecipanti nelle famigerate Antologie…
E così via.
Giorgio Linguaglossa
IL GRANDE PROGETTO: USCIRE DAL NOVECENTO
…quello che rimane da fare è il tragitto più lungo e tortuoso: appunto, uscire dal Novecento. Infrangere ciò che resta della riforma gradualistica del traliccio stilistico e linguistico sereniano ripristinando la linea centrale del modernismo europeo. È proprio questo il problema della poesia contemporanea, credo. Come sistemare nel secondo Novecento pre-sperimentale un poeta urticante e stilisticamente incontrollabile come Alfredo de Palchi con La buia danza di scorpione (1947)? Diciamo che il compito che la poesia contemporanea ha di fronte è: l’attraversamento del deserto di ghiaccio del secolo sperimentale per approdare ad una sorta di poesia sostanzialmente pre-sperimentale e post-sperimentale (una sorta di terra di nessuno?); ciò che appariva prossimo alla stagione manifatturiera dei «moderni» identificabile, grosso modo, con opere come il Montale di dopo La Bufera (1956) – (in verità, con Satura – 1971 – Montale opterà per lo scetticismo alto-borghese e uno stile intellettuale antidemotico, uno stile in diminuendo che avrà una lunghissima vita ma fantasmatica, uno stile da larva, da «ectoplasma» costretto a nuotare nella volgarità della nuova civiltà dei consumi. Consideriamo adesso un grande poeta di stampo modernista come Angelo Maria Ripellino degli anni Settanta: da Non un giorno ma adesso (1960), all’ultima opera Autunnale barocco (1978), passando per le tre raccolte intermedie apparse con Einaudi Notizie dal diluvio (1969), Sinfonietta (1972) e Lo splendido violino verde (1976), dovremo ammettere che la linea centrale del secondo Novecento è costituita dai poeti modernisti. Come negare che opere come Il conte di Kevenhüller (1985) di Giorgio Caproni non abbiano una matrice modernista? La migliore produzione della poesia di Alda Merini la possiamo situare a metà degli anni Cinquanta, con una lunga interruzione che durerà fino alla metà degli anni Settanta: La presenza di Orfeo è del 1953, la seconda raccolta di versi, intitolata Paura di Dio con le poesie che vanno dal 1947 al 1953, esce nel 1955, alla quale fa seguito Nozze romane e; nel 1976, il suo lavoro più impegnativo: La Terra Santa. Ragionamento analogo dovremo fare per la poesia di una Amelia Rosselli, da Variazioni belliche (1964) fino a La libellula (1985); il suo è un personalissimo itinerario che non rientra né nella tradizione né nell’antitradizione. La poesia di Helle Busacca (1915-1996), con la fulminante trilogia degli anni Settanta: I quanti del suicidio (1972), I quanti del karma (1974), Niente poesia da Babele (1980), è un’operazione di stampo schiettamente modernista.
Un tirocinio ascetico la cui spia è costituita da uno stile intellettuale-personale con predilezione per gli attanti astratti (la Rosselli), una predilezione per gli attanti concreti (la Merini), e per il vissuto-concreto (la Busacca), spinge questa poesia verso una spiaggia limitrofa e liminare a quella del tardo Novecento sempre più stretta dentro la forbice: sperimentalismo-orfismo. Direi che il punto di forza della linea modernista risiede appunto in quella sua estraneità alla forbice imposta dalla ideologia stilistica dominante.
La forma della «rappresentazione» di questa poesia, il suo peculiare tratto stilistico, il tragitto eccentrico, a forma di serpente che si morde la coda, è qui un rispecchiamento del legame «desiderante» della relazione che identifica l’oggetto da conoscere e lo definisce in oggetto posseduto. Gli atti «desideranti» (intenzionali) del soggetto esperiente definiscono l’oggetto in quanto conosciuto e, quindi, posseduto. Di fronte al suo «oggetto» questa poesia sta in relazione di «desiderio» e di «possesso», oscilla tra desiderio e possesso; è un sapere dominato dalla nostalgia e dalla rivendicazione per il mondo un tempo posseduto e riconosciuto. È perfino ovvio asserire che soltanto il riconoscibile entra in questa poesia, con il suo statuto e il suo vestito linguistico, mentre l’irriconoscibile è ancora di là da venire, resta irriconosciuto, irrisolto e, quindi, non pronunziato linguisticamente. La formalizzazione linguistica non può che procedere attraverso il «conosciuto», il «noto». Questo complesso procedere rivela l’aspetto stilistico (intimamente antinomico) di una poesia attestata tra il desiderio e la rivendicazione di un mondo «altro», tra la vocazione e la provocazione, tra il lato riflessivo e il lato cognitivo dell’intenzione poetica. Di fatto, non si dà intenzione poetica senza una macchina desiderante dell’oggetto (con il suo statuto linguistico e stilistico). La poesia che si fa strada consolidandosi appresso alla propria ossatura linguistica allude al tragitto percorso dalla contemplazione alla rivendicazione. Sembra una tautologia, la Poesia Modernista degli anni Settanta resta impigliata dentro l’ossatura del paradigma novecentesco: ma non quello maggioritario, eletto a «canone» (attraverso le primarie e le secondarie delle istituzioni stilistiche egemoni), ma quello laterale, e ben più importante, che attraversa la lezione di Franco Fortini passando per la poesia di un Angelo Maria Ripellino, fino a giungere ai giorni nostri.
La contro rivoluzione al linguaggio poetico sclerotizzato del post-orfismo e del post-sperimentalismo è impersonata dal destino di un poeta scomparso all’età di 36 anni: Salvatore Toma. Il suo Canzoniere della morte (edito con venti anni di ritardo nel 1999), ci consegna il testamento di una diversità irriducibile vergato con il linguaggio più antiletterario immaginabile. Una vera e propria liquidazione di tutti i manierismi e di tutte le oreficerie, le supponenze, le vacuità dei linguaggi letterari maggioritari. Affine al poeta pugliese è il tragitto del lucano Giuseppe Pedota con la riproposizione di un personalissimo discorso lirico (Acronico – 2005, che raccoglie scritti di trenta anni prima) che sfrigola e stride con l’impossibilità di operare per una poesia lirica dopo l’ingresso nell’età post-lirica: propriamente, nella post-poesia.
Una direzione «in diagonale» è invece quella del piemontese Roberto Bertoldo, il quale si muoverà alla ricerca di una poesia che si situi fuori dal post-simbolismo (salvando di questo il suo contenuto di verità), con opere come Il calvario delle gru (2000) e L’archivio delle bestemmie (2006). Nell’ambito del genere della poesia-confessione, già dalla metà degli anni Ottanta emergono Sigillo (1985) di Giovanna Sicari e, all’inizio degli anni Novanta, Stige (1992) di Maria Rosaria Madonna, una delle maggiori poetesse del novecento della quale Progetto Cultura di Roma ha pubblicato in questi giorni Stige. Tutte le poesie (1990-2002) pp. 150 € 12; ricordo qui anche Altre storie per album di Giorgia Stecher (1996).
Nella poesia di Roberto Bertoldo vi sono dei cunicoli sotterranei tra i diversi gradi di esperienza che l’oggetto linguistico rivela, v’è un continuum (topologico e metaforico), salti semantici e metaforici, si rinviene una retorizzazione di stampo modernista (né in posizione di punta né in posizione di retroguardia), una «lontananza» dall’oggetto da sedimentare nell’impianto stilistico. L’io percipiente contempla e, contemplando, reclama l’oggetto del suo desiderio. La riproposizione della centralità del soggetto percipiente è qui un passo obbligato: la condanna degli «oggetti» e della «Storia». Bertoldo individua una via di uscita dalla frammentazione dell’«oggetto» e dalla dissoluzione del «soggetto» attraverso la metafora: due discontinuità che si sommano, anzi, si sovrappongono. E si elidono. La continuità della percezione si converte in interferenza, intermittenza, simbiosi anche stilistica che si risolve nella «cicatrice» della metafora. Poesia che tenta la costruzione di un argine al problema del «vedere», anzi, della «cecità» propria del minimalismo (tutto incentrato sulla riproposizione della centralità di un «io ingenuo» e acritico che economizza nell’atto del vedere e travasa il problema nell’atto del commentario agli eventi della cronaca).
Nell’ambito del «cultismo decorativo» va ascritta una certa poesia, esemplare il caso di Francesco Nappo i cui libri pubblicati nel 2008 sono stati scritti negli anni Novanta: Genere e Requie materna ora in Poesie 1979-2007 edito da Quodlibet (2008); lo sperimentare arcaico di Nappo si incontra con un dettato linguistico culto-ultroneo-intellettuale che ne fa una operazione sopraindividuale e sovrastorica, direi sovra stilistica (un ipercritico idioletto ragguagliabile al parametro piccolo-borghese della poesia italiana maggioritaria).
Mi soffermo qui sulla poesia del terzo periodo di Cesare Viviani che va dal 2000 ai giorni nostri: troviamo una tensione narrativa, la problematica per eccellenza del nostro tempo post-utopico: la mancanza di radici del soggetto nell’epoca della globalizzazione e della post-massa, la problematica svolta va di pari passo con uno stile de-territorializzato e minimal, quasi didascalico, astratto, o meglio, che si è liberato del «soggetto». Viviani scrive una sorta di auto riflessione in versi che unisce il sotto genere della considerazione con quello dell’espressione aforistica e saggistica, un modo di scrivere che potremmo definire «orale». Nel 2000 esce Silenzio dell’universo, seguiranno Passanti (2002), La forma della vita (2005), Credere all’invisibile (2009).
Segnalo infine due poeti significativi della Generazione degli anni Dieci: Letizia Leone con L’ora minerale, (2004); Carte Sanitarie, (2008); La disgrazia elementare (2011); Confetti sporchi (2013) e Donatella Costantina Giancaspero con Ma da un presagio d’ali (2016) poetesse che si muovono in direzione di un modernismo che tenta di liberarsi delle ipoteche stilistiche tardo novecentesche alla ricerca di un linguaggio che si mantenga, pur in equilibrio precario e antinomico, in contatto con la lingua di relazione.
Ciò che emerge da questi brevi cenni è che è necessario che la poesia rompa le righe del politically correct, che occorre deragliare da un certo impiego (ormai consunto) di un certo «quotidiano» e di un certo linguaggio «mitopoietico» divenuto ancillare e tautologico. È venuto il tempo di ripensare la storia della poesia italiana del secondo Novecento, individuare una diversa lettura in diagonale della poesia del Novecento, in mancanza di questa ricerca sarà difficile scrivere la poesia del futuro.
Emerge subito un problema: che non si dà soluzione stilistica alla de-territorializzazione del linguaggio poetico che si è avuto nel tardo Novecento, il problema è più ampio. In verità, i linguaggi poetici dell’epoca mediatica possono al massimo prendere in prestito la de-territorializzazione (dall’empiria dei linguaggi mediatici) per una infarinatura della modernizzazione linguistica; non riescono a trovare la soluzione stilistica ad un problema che stilistico non è. In altre parole, il linguaggio cosmopolitico con cui la quasi totalità della poesia contemporanea viene scritta, è un linguaggio de-nuclearizzato e de-vitalizzato (a prescindere dal pedale alto o basso che esso impiega, qui non si tratta di andare in bicicletta), un linguaggio che insegue (inconsapevolmente) la brevità e la sintesi dello spot pubblicitario, una sorta di traduzione in linguaggio lineare del linguaggio televisivo-mediatico (questo sì sinestesico!). Al parametro del linguaggio universale indotto dal villaggio mediatico, la poesia contemporanea si ribella (anzi si maschera) adottando una stilizzazione iperletteraria, accentuando gli aspetti pre-sperimentali e pre-critici e una «chiusura» marcatamente «intima», «squisita», «effabile», «affabile» etc..
Sorge una domanda, apparentemente ingenua: quali sono le esperienze significative (gli oggetti concreti) che la poesia deve prendere in considerazione? Inoltre, la mancanza di un «luogo», di una polis, quali conseguenze hanno (e avranno) sull’avvenire e il presente della poesia? Di qui il bisogno di rispondere a queste domande, di ricostruire delle parentele e dei legami parentali con altri poeti della contemporaneità, quasi che la consanguineità potesse sopperire alla mancanza di sangue. Così, sottratta al «luogo», la migliore poesia contemporanea tenta di ricostruire e riallacciare i rapporti con la grande tradizione del Novecento. È questa la sua problematica mission.
Quello che rimane oggi, a distanza di quasi cinquanta anni, della poesia con impianto narrativo-autobiografico, una volta caduta l’impalcatura ideologica dell’epoca pre-modernistica, si rivela essere una colloquialità atopica e post-utopica, una intimità autotelica infirmata e riformulata, uno spostamento-spaesamento dell’«io» egolalico. La poesia dialogo con l’interlocutore è diventata problematica, è diventata un rimuginare sulla problematicità di un dialogo interrotto e non più recuperabile. Il ricorso alla metafora è, in questa poesia, un vestito linguistico (che tende a nascondere o rivelare il contenuto di verità?). Ma è ancora possibile rappresentare un «contenuto di verità»?
Come è scritto nel risvolto di copertina del mio libro, La nuova poesia modernista italiana (1980-2010) : «Se il linguaggio della post-avanguardia entrava in rotta di collisione con i linguaggi della scienza e della modernità, la Nuova Poesia Modernista prende atto della crisi irreversibile di ogni linguaggio fondato sulla “differenza”, sullo “scarto”, sullo “statuto ambiguo”; e prende atto della mancanza di un fondamento su cui sia possibile poggiare la costruzione poematica. La Nuova Poesia Modernista è il tipico e più maturo esempio di una poesia sopravvissuta dopo la bancarotta dell’ontologia, tra Heidegger e Wittgenstein. L’ontologia negativa di Heidegger, per il quale «Essere è ciò che non si dice», tendeva a spostare l’asse del logos poetico novecentesco più sul non-detto, sui silenzi tra le parole, ed infine, sul silenzio tout court. Il nichilismo era il precipizio entro il quale precipitava e periclitava tutta l’ontologia heideggeriana. Per contro, il linguaggio poetico novecentesco minacciava di periclitare, sull’orlo del nichilismo, nel compiuto silenzio della poesia post-celaniana. L’impossibilità di approdare ad una conclusione, in Heidegger, è totale: il pensatore è poeta, il silenzio è l’essenza del linguaggio, esso è il luogo atto a esprimere l’essenziale come non-dire».
Giorgio Linguaglossa
1 giugno 2018 alle 7:42
Il modo di produzione della cosiddetta «poesia» ha assunto una velocità edittale forsennata, dinanzi alla quale non c’è Musa che tenga, che riesca a stare dietro a questa velocità ultrasonica. La Musa è lenta, ama la lentezza, è gentile, si deposita, giorno dopo giorno, sugli oggetti e le cose come polvere… bisogna far sì che la polvere si sedimenti… soltanto gli oggetti e le cose impolverate possono trovar luogo in poesia, soltanto le cose dimenticate… tutto ciò che ricordiamo, ciò che la dea (un’altra dea!) Mnemosine ci dice è frutto del calcolo e della cupidigia. Alla strategia di Mnemosine dobbiamo opporre una contro_strategia, dobbiamo dimenticare i ricordi, dobbiamo dimenticare i falsi ricordi che l’Inconscio ci pone sotto gli occhi, dobbiamo scavare più a fondo. La Musa è nemica di Mnemosine, ed entrambe sono segretamente alleate con un loro progetto di raggiro e di deviazione della nostra mente… dobbiamo perciò porre in atto delle strategie di contenimento e di inveramento dei ricordi, delle rammemorazioni. Dinanzi alle sciocchezze imbarazzanti che la poesia dei nostri tempi ci propone rimango a volte allibito ed annoiato, ma dobbiamo farci forza e sopportare con tenacia questa montagna di banalità…
Il fatto è che le parole sono diventate «fragili» e «precarie», si sono «raffreddate», di contro alla volontà della tecnologia dispiegata del mondo di oggi. Il mondo è cambiato, non è più quello di ieri. Anche le parole sono cambiate, hanno mutato colore e tonalità, e la poesia non può non fare altro che adottare le parole che trova, siano esse fragili, precarie, raffreddate o altro ancora…
Di frequente, davanti a tanta arte contemporanea mi assilla il dubbio che un eccesso di armonia, un sovrappiù di lucidatura del pavimento, dell’argenteria e degli stivali di pelle lasciati in un angolo non comporti anche il sospetto, in chi osserva dal di fuori, che dentro l’appartamento profumato e lindo con deodorante da supermarket non si nasconda, in qualche armadio, il cadavere messo sotto naftalina di qualcuno di famiglia. Insomma, se questo eccesso di deodorante non serva che a nascondere il lezzo ingombrante e intollerabile di un cadavere. E allora mi viene voglia di indagare oltre la cortina di nebbia del deodorante, al di là delle lucidature dell’argenteria per scoprire l’innominabile cadavere che si cela da qualche parte, nascosto in qualche latebra del soggiorno di casa. Allora, apro le finestre, voglio far entrare un po’ di aria fresca. Mi viene il sospetto che tutta quella modanatura, quella lucidatura non sia altro che Kitsch, ottimo, metallico, rassicurante Kitsch. Addirittura, anche e soprattutto là dove si rinviene tanta trasandatezza metrica posta in bella evidenza, proprio là si rivela l’intenzione forzosa di sporcificare la lucidatura posticcia. Il che è anche peggiore del male che vorrebbe travisare.
Giorgio Linguaglossa
1 giugno 2018 alle 8:01
Proviamo ad avvicinarci ad una idea inconsueta, alla idea di far ri-diventare gli «oggetti», «cose». Forse siamo diventati troppo adulti, troppo abituati a considerare le «cose» equivalenti degli «oggetti» che non sappiamo più la differenza tra gli «oggetti», e le «cose». Che cos’è un oggetto? Che cos’è una «cosa»? E come si fa ad entrare all’interno della «cosa»? Come si fa ad adoperare una «cosa»? Ma, una «cosa» si può adoperare? Quando è che una «cosa» diventa un evento esteticamente tracciabile? Che rapporto c’è tra un «evento» e una «cosa»? – Ecco, io direi che la poesia italiana ha trascurato da sempre questo piccolo problema: quando gli oggetti cessano di essere «oggetti» e diventano «cose». È soltanto a quel punto che può sorgere una tracciabilità per la poesia. Io la metterei così: la «cosa» è un oggetto simbolico che ha iniziato ad irradiare segnali significativi. Ad un certo punto avviene che un «oggetto» è muto per il linguaggio ordinario ma non per il linguaggio simbolico per eccellenza quale è il linguaggio poetico, e inizia a «parlare». E questo suo «parlare» è il discorso poetico.
