
foto di Lorenzo Pompeo
Vincenzo Mascolo è nato a Salerno nel 1959, vive e lavora a Roma. Nel 2004 ha pubblicato la raccolta Il pensiero originale che ho commesso, Edizioni Angolo Manzoni. Con la casa editrice LietoColle ha pubblicato nel 2009 Scovando l’uovo (appunti di bioetica). Nel 2010 un estratto del libro inedito Bile è stato pubblicato nell’antologia Lietocolle Orchestra – poeti all’opera (numero tre), curata da Guido Oldani. Per LietoColle ha anche curato le antologie Stagioni, insieme a Stefania Crema e Anna Toscano, La poesia è un bambino e, con Giampiero Neri, Quadernario – Venticinque poeti d’oggi. Q. e l’allodola, Mursia, 2018. È il curatore di Ritratti di poesia, manifestazione annuale di poesia italiana e internazionale promossa dalla Fondazione Roma.
Ermeneutica di Giorgio Linguaglossa
Abbiamo perduto la patria metafisica del novecento
e questo libro di poesia di Vincenzo Mascolo a suo modo ne prende atto, dice che non è più possibile alcun «oltrepassamento» dello sperimentalismo del secondo novecento, se non saltandolo di netto all’indietro, che non c’è stata alcuna metafisica di «quella» poesia, e per metafisica intendo quelle parole che appartengono a una patria di parole comuni, una patria che fonda una comunità.
È così tanto tempo che la poesia italiana ha smarrito la sua patria metafisica, almeno, a far luogo da Le ceneri di Gramsci (1957) di Pasolini, e dalla poesia dell’ultimo Bertolucci di La camera da letto (1984 e 1988) (lì le parole abitano ancora mirabilmente un’unica patria) che a noi posti nel presente ciò sembra del tutto accettabile, normale. Se mettete in fila tutte le parole del lessico di quelle opere, vi accorgerete che quelle parole abitano una medesima Grundstimmung, una medesima tonalità emotiva dominante.
Dopo di allora la poesia italiana perderà progressivamente il vocabolario della poesia. Mi spiego meglio, nelle opere degli autori più giovani accade che il vocabolario viene ad essere enfatizzato, diventa occasione di elefantiasi lessicale, viene introdotto in quel vocabolario il lessico del quotidiano giornalistico, il quotidiano del mondo mediatico ma senza alcun filtro preventivo, senza predisporre alcun salvagente; ci saranno a disposizione, utilizzabili, molte, troppe parole, dissimili e variegate, e si perderà addirittura la memoria della loro originaria comunanza gemellare. Non dico che dopo di allora non siano apparse opere significative nella poesia italiana, ne cito tre per tutte: Lo splendido violino verde (1976) di Ripellino, I quanti del suicidio (1972) di Helle Busacca e Altre foto per album (1996), opera postuma di Giorgia Stecher, opere che stanno lì a dimostrare questa mia affermazione, dico una cosa diversa, dico che nelle opere che sono venute dopo si andrà indebolendo ciò che tiene insieme le parole comuni di un’epoca e di una lingua dentro una cornice, una rete tono e fono simbolica, la cornice di una lingua e di un’epoca. Qui non si tratta della cornice di un quadro di proprietà privata che può essere alienato a piacimento o che i singoli poeti possano disporre e alienare liberamente, essa (la cornice, la patria metafisica) è inalienabile, indisponibile e inalterabile, al massimo i poeti la possono condividere quando si creano delle situazioni storiche e spirituali singolarissime, quando in taluni rari momenti della storia di una comunità linguistica vengono a coincidere distinti momenti dello spirito di un’epoca, allora viene ad esistenza, diventa percettibile la struttura trascendentale di una comune patria linguistica.

nel tempo che per me si fa feroce/ quelle parole che sono sfiorite:/ rosa rosario rosa della croce
Scrive Vincenzo Mascolo:
nel tempo che per me si fa feroce
quelle parole che sono sfiorite:
rosa rosario rosa della croce.
Le parole della poesia si sono allontanate, sono «sfiorite». Per un poeta del nostro tempo diventa sempre più problematico intercettarle, catturarle, e allora non resta che lasciarsi andare, abbandonarsi sulla criniera di un’onda sonora che un tempo lontano ancora permetteva l’esistenza o la sopravvivenza della poesia. Non è un caso che l’andamento tono simbolico e strofico della poesia di Mascolo si rivolga al crepuscolarismo del primo novecento come alla scuola più consona alla odierna sensibilità della poesia attuale. Del resto, cos’altro è questo smarrimento di Vincenzo Mascolo se non una dolorosa presa d’atto che non ci sono più disponibili le parole «nuove» e che bisogna ritornare all’«antico» per poterle prendere all’amo?
Tutta la prima parte del libro è una presa di distanza dallo sperimentalismo di Raymond Queneau, quella sì che era una scuola poetica priva di una patria metafisica, lì le parole circolavano liberamente e senza alcun timore di respingimento. Oggi, sembra dirci Mascolo, quelle parole ci sono divenute estranee, non le comprendiamo più, quel gioco dei significanti con i significati ci appaiono oscuri e senza senso, un gioco colloquiale, da ottimati dello spirito. È tutta la civiltà del secondo novecento che viene ad inabissarsi. Il poeta romano parte da qui per fare una poesia dal cabotaggio breve, con una navigazione a vista, tenendo sempre presente però la terraferma; è una poesia apatica, quasi priva di foné, che muove i propri passi in modo empirico.
Che ce ne facciamo di una patria metafisica delle parole sempre più lontana,
estranea e indifferente, di cui non ne conosciamo il contenuto, l’indirizzo, gli abitanti, una patria che ci fa sentire inidonei e inospitati intrusi della «casa dell’essere»? Quella «casa» ormai appare essere sempre meno la nostra «casa» ma un «appartamento» ammobiliato, con suppellettili e ninnoli a noi estranei, indifferenti, che si presenta sempre più come un luogo indisponibile, inaccessibile, inospitale, irriconoscibile.
Mi sorge il sospetto che quella «casa dell’essere» sia ormai divenuta un qualcosa che non sappiamo più riconoscere, che quella lingua che si parla laggiù sia una lingua straniera, dai suoni imperscrutabili e incomprensibili, una lingua confezionata con i deodoranti da supermarket. Mi sorge il sospetto che con quella lingua sia ormai improponibile scrivere poesia, non abbiamo più il lessico, non abbiamo più una grammatica e una sintassi che ci possa accompagnare nel nostro viaggio; mi sorge il sospetto che abbiamo perduto la patria metafisica delle parole.
Che cos’è una patria metafisica?
Una patria metafisica delle parole la si costruisce in piena consapevolezza, e la può costruire soltanto una civiltà, non un singolo. È soltanto quando una patria metafisica delle parole inizia a declinare che si aprono delle «falle» e si inizia ad intravvedere un’altra luce, e con essa altre «cose» che prima non vedevamo. Non si tratta soltanto di una fotologia o di una riforma ottica delle parole come molti autori apprezzati di oggi fanno, come spesso in questi ultimi decenni si è fatto, maquillage e nient’altro, ma di un vero «regno delle cose» che viene avvistato. Solo a quel punto sorgono, possono sorgere, le parole «nuove», ma per «nuovo» non intendo le parole-banconote che escono dalla zecca degli azzeccagarbugli ma le parole comuni, porose, i frammenti, i frantumi. E allora non resta che ricostruire ciò che è stato decostruito, raccogliere i «frammenti» di quelle parole morte che sono state calpestate e spezzate, e indugiare, prendere una distanza, rallentare il passo e, se del caso, fermarsi pensierosi, non oltrepassare ciò che è non oltrepassabile, accettare i nostri limiti, perché noi siamo sempre in cammino verso una nuova casa dell’essere, dobbiamo sempre istituire un rapporto amicale con il linguaggio, quel linguaggio che è stato fatto sloggiare dalla «casa» ed è rimasto preda delle intemperie, del gelo e del raffreddamento delle parole. Quelle parole raffreddate sono le uniche parole che abbiamo, non ne disponiamo di altre, sono loro che ci possiedono… E allora bisogna scaldarle, bisogna trovare una nuova abitazione riscaldata, con una buona stufa… Forse, questo cammino altro non è che un momento del Ge-Schick dell’essere, del nostro essere, un tratto di quella peripezia dello spirito che occorre accettare e perseguire.
Cantami, o diva, l’eterna lotta
tra i significanti e i significati
narrami l’attesa tra gli eserciti schierati
del segnale che arrosserà quel campo
i riti per propiziare la vittoria
cantami la furia di quella battaglia
che non ha avuto vincitori e vinti
raccontami la torsione dei corpi
il sudore che impregna anche il terreno
la tensione dei muscoli allungarsi
quando sferrano colpi, nel ritrarsi
fammi sentire gli zoccoli che battono
i nitriti, il clangore delle armi
il cozzo delle spade sugli scudi
le grida per gli squarci delle lance
narrami le ferite, la paura
la polvere che copre chi è caduto.
Cantami, o diva, l’ira del poeta
la sua fatica che trasuda versi:
portami il sangue della sua poesia.

Ecco il senso di questo encomio alla Musa di Vincenzo Mascolo.
«L’impostura più grande, la folle illusione, la follia estrema è che il nome e la cosa coincidano.» Scrive Pier Aldo Rovatti:1]
«L’illusione che si ripresenta ad ogni frase è che il nome e la cosa coincidano e che il soggetto parlante sparisca: sparisca non come enunciante della frase ma perché vi ha preso completamente dimora. L’unico modo di maneggiare questa illusione non è di farla sparire, ma al contrario di riconoscerla, di farla pesare sulla frase: attraverso il margine, la paradossalità che resta praticabile, in un gioco inevitabilmente in perdita e che deve sapere di esserlo».2]
Mascolo assume in pieno nella sua poesia la condizione di perdita, di finitezza e di pragmatica finitudine dell’uomo che abita una zona di frontiera, l’unica soglia abitabile, anzi l’unica dimora possibile che è data all’uomo di oggi. Le condizioni di inabitabilità del luogo e della lingua coincidono, ed è questo, propriamente, il «luogo della poesia moderna». Non sono più condivisibili l’esigenza dello stile né il tema del linguaggio, oggi il poeta è rimasto orfano di entrambi: dello stile e del linguaggio condiviso o non condiviso con una tradizione, e questa duplice condizione estraneità e di orfanità è propria della poesia più esigente e avveduta dei giorni nostri.
1] P.A. Rovatti, Abitare la distanza, 2001 p. 32
2] Ibidem
 Vincenzo Mascolo
Vincenzo Mascolo
Poesie di Vincenzo Mascolo da Q. e l’allodola, Mursia, 2018
Oh, Queneau
non basta più esercitarsi nello stile
come tu sapevi fare inanellando
notations, hellenismes, le contre-pettéries
e tutte le altre tue diavolerie
che aprivi come nuove fioriture
nelle terre inaridite che solcavo
con strumenti quasi umani zolla a zolla
per offrire a Cerere il raccolto
generato in primavera dai miei semi.
*
Non è rimasta immune la poesia
che ora sento spenta, prosciugata
del suo soffio vitale, di energia
e sembra spesso quasi soffocata
perché si sente stringere la gola
da grumi di realtà già masticata.
Dov’è silenzio, dove la parola
che riproduce il suono della vita
qual è la corda giusta della viola
*
Levatevi dal sonno, dalle tombe
o miei Penati, numi tutelari
i vostri versi siano come bombe
sui miei pensieri già crepuscolari
sulla penombra che dalla mia mente
avvolge cieli, campi, vie biliari.
Io odio questo vuoto questo niente
che si diffonde come la gramigna
e scava dentro me profondamente
*
Non c’è preghiera né giaculatoria
che possa darmi, padre, la salvezza
e mi condannerà la vanagloria
a ricercare sempre la bellezza
nella radura dove si nasconde
la fonte dell’eterna giovinezza.
Lo senti come agita le fronde
il vento della notte che sospinge
il battito del tempo, mi confonde
*
Oh, Queneau
per quelle terre, sai, cammino ancora
ma non ho più strumenti
e non ho fiato
per intenerire quelle zolle
ormai pietrificate come il seme
che offrivo in sacrificio alla mia dea
come i miei versi, come il mio silenzio
vieni, notte,
a sciogliere il silenzio.
*
Oh, Queneau Queneau
non basta adesso, credi, non mi basta
stringere, costringere, forgiare la parola
per disegnare le ombre sopra i muri
figure che volteggiano nell’aria
vagule, blandule, leggere
forme senza mai sostanza
nemmeno la volatile dei sogni
corpuscoli di polveri sottili
che arrochiscono la voce dei poeti.
*
Oh, Queneau
non sono poi così sottili
le polveri nell’aria in questo tempo
che si posano sugli occhi dei poeti
formando a poco a poco come un velo
(‘la cataratta dei poeti’, dice Guido
che Salvatore vuole a ogni costo
rimuovere dal proprio cristallino
per scorgere oltre il ferro delle grate
la fuga di una nuova prospettiva).
*
Oh, Queneau
i poeti sopravvivono a fatica
costretti a rovistare tra le scorte
delle loro animule sfibrate
per riprendere il ritmo regolare
del battito del cuore e del respiro.
Non c’è più tempo per i tuoi esercizi
non è più tempo questo per lo stile:
ormai del poco fiato che rimane
è meglio farne voce per la bile.
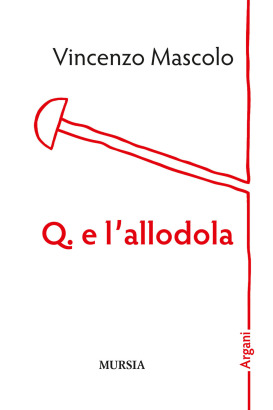
Oh, Queneau
Queneau
parlavo seriamente della bile
perché stanno esaurendosi le scorte
delle anime ridotte al lumicino
e per nutrire ancora una speranza
che adesso si fa sempre più sottile
ai poeti non resta che affilare
parole sulla pietra per raschiare
il fondo limaccioso del barile.
*
Oh, Queneau, Queneau
Queneau
per poi cercare cosa
mi domando
se ormai non è rimasto proprio nulla
nemmeno sotto le assi del barile
se nulla muove il sole e le altre stelle
e il mondo è governato
in questo tempo
da leggi che è impossibile capire.
*
Oh, Queneau
e come possono comprenderle i poeti
che prima di affilare le parole
affondano il pensiero nelle pieghe
della materia oscura che li avvolge
in cerca del principio universale
sia caso oppure forza del destino
il nostro arbitrio già determinato
coscienza che affluisce alla ragione
sia legge naturale, l’Ego, l’Uno.
*
Oh, lo so
Queneau, lo so
potresti allora dirmi che il reale
per i poeti è cosa ben diversa
da questo affaccendarsi quotidiano
che loro riconoscono i confini
dell’anima costretta nella forma
che muta, evolve, vira
si trasforma
cambiando il punto dell’osservazione.
*
Oh Queneau
Queneau
ma dimmi, a cosa servono i poeti
e tutta la fatica quotidiana
per svellere dall’ombra le parole
Queneau, sai dirmi a cosa può servire
se i loro corpi vedo evaporare
come la rugiada del mattino
se i poeti attraversano invisibili
la linea luminosa del mattino.
*
Oh, Queneau, qui dicono che scrivere poesia sia gesto che si compie per la polis, si dice serva come resistenza. Resistere poi a cosa mi domando: al vuoto
all’incultura, all’incoerenza, al buio che affligge l’etica, alla volgarità imperante, al malgoverno, all’impoverimento del linguaggio oppure solamente
alla nostra indifferenza? Queneau, non è delimitata la poesia, non ha finalità né appartenenza. Accade per fatto naturale, come un frutto di stagione, talvolta
ci sorprende come un temporale estivo che scuote anche le zolle e libera l’odore della terra, impregna l’aria e gli abiti e smuove dentro noi la torba del
ricordo. Eppure sai, Queneau, non è nemmeno questo risalire dei fumi e degli umori della terra, non è la pioggia estiva che risveglia la trama di memoria e di
radici, non è soltanto tutta la bellezza che ci sorprende e che ci meraviglia, non è nemmeno questo solamente la cosa che chiamiamo la poesia.
*
Oh, Queneau
trascorro notti insonni comparando
poetiche teorie sulla poesia forme chiuse versi liberi prosastici
la metrica gli accenti le metafore il ritmo la sua musica le immagini
terzine strofe ottave stanze rime endecasillabi i doppi settenari alessandrini
ABAB ABAB CDC
il canone del nostro Novecento versi lirici civili quotidiani d’amore religiosi minimali classici moderni d’avanguardia versi eterni transeunti di ogni
continente lingua forma visioni urgenze ispirazioni l’etica l’estetica
il linguaggio generazioni entranti entrate uscite uscenti
ABBA ABBA CDE
Oh, Queneau
trascorro notti insonni
ma ancora mi domando
se sia davvero questo solamente
la cosa che chiamiamo la poesia.
