


(Grafiche di Lucio Mayoor Tosi con i poeti della Nuova
Ontologia Estetica e Vincenzo Petronelli)
Vincenzo Petronelli è nato a Barletta l’8 novembre del 1970. Sono laureato in lettere moderne con specializzazione storico-antropologica, risiedo ad Erba in provincia di Como, dove sono approdato quattordici anni fa per amore di quella che sarebbe poi diventata mia moglie ed ho una bambina 10 anni. Dopo un primo percorso post-laurea che mi ha visto impegnato come ricercatore universitario nell’ambito storico-antropologico-geografico e come redattore editoriale, ho successivamente intrapreso un percorso professionale nel campo della consulenza aziendale, che mi ha condotto al mio attuale profilo di consulente in tema di comunicazione ed export; nel contempo proseguo nel mio impegno come ricercatore in qualità di cultore della materia, occupandomi in particolare di tematiche inerenti i sistemi di rappresentazione collettiva, l’immaginario collettivo, la cultura popolare e la cultura di massa. Inoltre abbraccio un ampio spettro di interessi culturali che spaziano dalla letteratura, alla linguistica, alla musica, al cinema, allo sport. Per quanto concerne la poesia, è una passione che mi accompagna ininterrottamente dall’età di sedici anni e che ho coltivato in modo febbrile nel corso del tempo, divorando libri di opere di poeti provenienti dalle più disparate tradizioni ed aree geografiche, per poi cominciare a comporre mie poesie in modo più consapevole dall’età di ventinove anni. Attualmente faccio parte del gruppo letterario Ammin Acarya di Cantù.


Vincenzo Petronelli. Dichiarazione di poetica
La poesia ha sempre costituito per me il punto di convergenza e sublimazione della totalità del mio “cosmo” intellettuale, il ganglio attorno cui si annodano i miei amori per la letteratura e la storia, le scienze sociali e la linguistica, il folklore e la musica, il cinema e lo sport, in un concetto di “poesia totale” o come più mi piace definirla, poesia antropologica. In ciò risiede la diversità di canoni linguistici e moduli espressivi che da sempre cerco di perseguire, attitudine figlia di una formazione poetica eclettica maturata assiduamente nel corso degli anni e snodatasi attraverso l’incontro con poeti, tradizioni e filoni i più disparati nello spazio e nel tempo; dalla poesia italiana novecentesca, alle tradizioni poetiche di area ispanofona e lusofona, slava, anglofona (irlandese in particolare), persiana, araba, cinese (in particolare la produzione dell’epoca T’ang), interessandomi tanto alla poesia culta che a quella di espressione popolare. E’ così che partito da un’impostazione iniziale prevalentemente lirica, sono poi giunto, incarnando tale visione “olistica” (incapace per natura di rimanere ingabbiato dentro definizioni stilistiche o concettuali) a cimentarmi con scritti di impostazione più narrativo – prosastica giungendo anche ad abbracciare il genere comico, poiché da sempre l’ironia è uno degli elementi caratterizzanti la mia personalità. Dal punto di vista linguistico, amo passare dall’italiano alle miei idiomi locali (barlettano e andriese, mare e terra insieme) alternando occasionalmente anche scritti in alcune delle lingue straniere di mia conoscenza. Nuclei centrali della mia poesia sono il rapporto con la terra (in una sorta di interscambio continuo tra materia e spirito), il rapporto con la memoria, il mondo e le culture popolari mediante la narrazione della loro quotidianità che inevitabilmente si fa storia.
Il mio afflato per la poesia è sempre stato accompagnato dall’amore per la parola e per la straordinaria possibilità offerta dall’arte poetica di plasmare, modellare, disarticolare e ricomporre lo stesso suono o lemma in universi di significato continuamente cangianti, facendone materia plastica, sino a giungere alla sublime possibilità di sovvertire e rimodulare i canoni precostituiti di ogni sistema linguistico. Ovviamente la catalizzazione verso la parola sussume l’interesse per la lingua, veicolatrice di cosmologie di significato culturale e strumento privilegiato di espressione antropologica; ciò mi ha condotto, già agli albori dei miei cimenti poetici ad abbinare le proprietà espressive di una lingua “colta”, quale è la nostra lingua nazionale, con le suggestioni “naturaliste” delle lingue locali (nel mio caso i dialetti o idiomi locali – che dir si voglia – delle mie due città, Barletta ed Andria), creando una sorta di “sincretismo stilistico” che culmina in una “popolarizzazione” del registro linguistico italiano ed al tempo stesso in una “liricizzazione” dei miei dialetti, storicamente estranei ad una vera eredità poetica che non sia quella macchiettistica dell’elzeviro paesano. Peraltro, ho sempre trovato che questo scomposizione e sovvertimento di canoni espressivi estremamente stimolante in termini creativi, grazie all’estrema libertà compositiva offertami, in cui il “meticciato” dei linguaggi si completa mediante il trapianto, nella mia versificazione, di modelli poetici derivanti da altre tradizioni legate alla mia formazione e maggiormente orientate verso una concezione popolare alta della poesia, attinente alla visione del mio progetto poetico. Lo si evince in particolare nei confronti del mio uso dei dialetti, in cui ho potuto godere dell’enorme privilegio di ritagliare loro su misura una sintassi poetica originale (essendo loro sconosciuti come accennavo, dei veri modelli pre-esistenti) per cui ad esempio diversi componimenti realizzati in dialetto, traggono in realtà motivo d’ispirazione in modelli irlandesi, slavi, ispanici, ecc. Tutto ciò mi consente oltretutto di rimanere al riparo, proprio per ciò che concerne le composizioni dialettali, dal rischio di una percezione “localistica” o peggio ancora “etnica” della mia produzione (elementi dai quali rifuggo decisamente) ed al contrario di evidenziarne i caratteri universali, poiché pur avendo per ontogenesi un rapporto forte (materico a volte) con la terra,in realtà ho sempre visto in tale matrice il trampolino e la bussola per proiettarmi verso il mondo. In tale contesto si pongono anche sperimentazioni che pur comparendo – finora almeno – in maniera più rarefatta, costituiscono parte dell’orizzonte del mio corpus poetico e che mi conducono alla composizione in alcune delle lingue estere di mia conoscenza, alla sovrapposizione di più lingue, fino al pastichelinguistico.
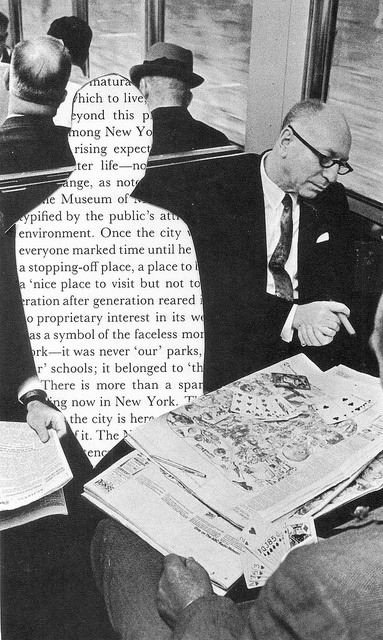
foto Richard Vergez
Giorgio Linguaglossa
statualità del linguaggio poetico e meridionalismo poetico degli autori del Sud
Pur con tutte le scriminanti a discarico della poesia di Vinvenzo Petronelli, mi sento di scagliare una freccia in parziale suo favore: direi che il suo meridionalismo è tipico della poesia in dialetto del Sud, tipica anche della autrice forse «migliore» della poesia in dialetto del Sud: Assunta Finiguerra. Il meridionalismo della poesia in dialetto del Sud purtroppo è una malattia endemica del Sud. Ci sarà pure una ragione di questo fatto? E infatti c’è, e la ragione sta nel mancato sviluppo nel Sud di una borghesia attiva e progressista, nel mancato sviluppo del Sud come, oserei dire, stato unitario (anche se aggregato alla repubblica italiana). La statualità di uno stato è molto importante anche per la poesia e per il linguaggio poetico. Voglio dire che c’è una equazione tra statualità o mancata statualità di uno stato e i linguaggi delle sue comunità linguistiche. E questo ha senz’altro una ripercussione anche sul linguaggio poetico di quelle comunità linguistiche,
Però, un elogio che mi sento di fare a carico di questa poesia è che non si tratta di una poesia low cost, come moltissima poesia romano milanese e di Pordenone e Mantova e altre località della villeggiatura poetica disseminate in italia; almeno qui siamo davanti ad una poesia che un tempo si definiva “onesta”. Certo l’onestà non basta a fare una poesia, così come l’onestà non basta a fare dei politici capaci, come vediamo nei 5Stelle, però è già qualcosa.
Esemplificando un po’ potremmo dire che c’è una poesia low cost che si può acquistare in ogni buon supermercato dello stile, in specie in epoche di saldi e compri tre paghi due: abbassando il registro stilistico, lo schema prosodico, espungendo le metafore, le metonimie, le anadiplosi, le catacresi, le anafore etc., desertificando la tradizione, succede che alla poesia non rimanga altro da fare che registrare, come succede in alcuni autori contemporanei, le ubbìe della vita quotidiana: una sorta di cronachismo borderline del tipo: “al mattino quando si alza a mio marito gli puzza l’alito”, oppure una sorta di iperrealismo ingenuo del tipo: “fontana, finestra, albero, mare”. Si tratta di un vero e proprio deposito di tecniche stilistiche ampiamente provate e assimilate dal corpo sociale della piccola comunità letteraria, e in tal senso queste tecniche sono ampiamente leggibili e digeribili. Per il vero, il problema della costruzione di una “nuova” poesia avrebbe richiesto un processo del pensiero molto più elevato e una gestazione molto più complessa che gli autori del minimalismo e dell’iperrealismo non sono affatto capaci di offrire.
Vincenzo Petronelli
U SPUSALIZZIE
Atténəmə jêrə də Cérəgnolə
manəsciavə i parolə accomə e curtiddə;
mamminəmə jêrə andrəsànə,
propriə u pajeisə d’i zappatourə e di bbábunə
ndò i dìibbətə pəsèvenə
accomə a na zochə ngánnə.
Na sciurnàtə appêsə də Márzə,
nonònnə facèttə mbáccə ‘a figghjə:
“Nan nə tənéimə daggè abbastánzə de uájə,
ng’i vuléimə scì a truè a fòrzə? Cə jə, tə fêtə
l’árjə ca tə nə vu scì da ddò?”, chə l’ucchjərə appəcciàtə.
‘A sêrə, doppə ca fərnavə də cusì,
mamminəmə assavə i fotograféje
da ìində o tərèttə,
adunénnə i pənzìirə nzìimə o ppànə da sope a távələ;
méndrə atténəmə sə sciavə a còlchə e sə sciuscelavə
ch’i rraggiunamìinde sou; u prèstətə da cercà a bánghə, a máchən-a novə,
i bastárdə ch’ i mannèvənə a schəmmunəchə.
Traduzione
Il matrimonio
Mio padre era di Cerignola
maneggiava le parole come coltelli;
mia madre era andriese,
proprio la città dei contadini e dei “va bene”
dove i debiti pesavano
come una corda intorno al collo.
Un giorno incerto di Marzo
mio nonno disse rivolgendosi a sua figlia:
“Non abbiamo già abbastanza guai,
da andarceli a cercare a tutti i costi? Cosa c’è, ti puzza
l’aria, che vuoi andar via da qua?”, con gli occhi accesi.
Alla sera, dopo che finiva di cucire,
mia madre tirava fuori le fotografie
dal cassetto,
raccogliendo i pensieri insieme al pane sul tavolo;
mentre mio padre andava a dormire e si gingillava
con i suoi ragionamenti; il prestito da richiedere in banca, la macchina [nuova,
i bastardi che gli portavano sfortuna.
IL VOLO
Gli occhi tornano sempre
dove si sono posati.
Così ogni notte
liberato il mio inquieto colombo,
raccolgo
come contrabbandiere di confine
il povero bagaglio dei miei ricordi
ed attraverso i sentieri tracciati.
Sono ampi spazi
disseminati nel bianco fragore di case
col volto dei millenni,
e suoni
riecheggianti nelle stanze
dalle strade mute,
voci di bambini
sospinti dal vento
per le valli.
Sono mani dure
ed occhi rugosi di contadini
asserragliati nelle loro memorie
squarciate dagli inverni,
e donne che cuciono
la trama sottile di un tempo impari,
inebriate di sole
che esonda dai muri d’ombra
le loro ali di cera.
Sono stazioni scomparse
tra anfratti di treni a vapore,
che rinfrangono accenti di giorni passati
mescolati
agli odori del mezzogiorno
ed alle grida dei venditori.
Sono sfumature di bianco e nero
e contorni di terra e sangue
che la storia
non cancellerà.
Gli occhi tornano sempre
dove si sono posati.
ENDRE ADY
Sopə a Murge l’alt-a déjə è assoutə l’autunnə;
ndruppəchènnə, d’a stràtə d’u Parədàne
nzìimə a l’árjə prênə d’a salzə de pumədourə,
u sendibbə.
Mə nə sciavə ch’a rámbə d’i Mònàchə a joscə
e tuttə ‘na vòltə u foumə d’i calarounə
mə jagnèttə də voucə ca sfuscèvənə vəlocə,
vùulə de sckázzamurìiddə.
M’attucchèttə l’autunnə, scialpəscènne i parolə
ca mə zumbèrənə ngánnə da rêtə ‘e prêtə d’i cásərə
e u sendibbə fuscì p’i trasunnèddə, ‘i scàlə,
i fənèstə maravəgliàtə.
Po ndrəsèttə a staggionə jalzèttə a cotə
e chə na rəsàtə l’autunnə sparəscèttə ‘o recone.
‘U pajéisə se ne scurdèttə a lèstə a lèstə, ma jej u vətìibbə
rêtə all’ômbrə du trênə p’a maréinə
Traduzione
Sulla Murgia è arrivato l’autunno l’altro ieri;
inciampando, dalla strada del Paredano
insieme all’aria pregnante della salsa di pomodori
mi arrivò.
Me ne andavo per la scalinata delle Monache nel pomeriggio
ed improvvisamente il fumo dei calderoni
mi riempì di voci sfuggenti, rapide,
folletti in volo.
Mi toccò l’autunno, balbettando parole
che mi fecero trasalire dalle pietre delle case
e lo sentì fuggire per le stradine, le scale,
le finestre sorprese.
Poi improvvisamente l’estate tornò ad agitare la coda
e con una risata l’autunno si nascose al riparo.
Il paese se ne dimenticò velocemente, ma io lo vidi
dietro l’ombra del treno per la marina.


CUNGÊDE
(P‘A MÓRTE DE NU PUÊTE GIARGIANÊSE)
Josce
allassàtə i fənèstə apèrtə
ca o segnôrə sté a murì!
A fənèstə sopə a Murgə
jə nu spècchiə,
na travèttə;
ddò jə uguàlə a ddéice
solə o marángə,
pelonə o cìilə;
ddò jə uguàlə
bənədittə
o pàne nèrghə,
lénguə də màrə
o de tèrrə.
(“Os meninos subiram pela figueira
para eles comerem os frutos;
desde aquì os posso olhar;
desde aquì os posso ouvir;
Ah, que dìa tão lindo
para eu animar a vida!”).
Joscə
allassàte i fənèstə apèrtə
ca o səgnôrə va déicə l’orazzionə!
Na saittêrə,
a Murgə jə na saittêr-a d’orə
d’orə biánghə
ca sə spəcchiascə
mbáccə o cìilə.
N’arcəpéinə,
a Murge je n’arcəpéinə d’argèndə
ca sciuppascə
u maləvèrmə
Íində a làne d’i nnuvələ .
(“Os camponesês sairam aos campos
para eles cortarem o trigo;
desde aquì os posso olhar;
desde aquì os posso ouvir:
que dìa tão lindo
para eu cantar da vida!”)
joscə
pə favorə
allassàtə i fənèstə apèrtə!
Hoje
por favor
deixai as janelas abertas!
CONGEDO
(IN MORTE DI UN POETA STRANIERO)
Oggi
lasciate le finestre aperte
che il signore sta morendo!
La finestra sulla Murgia
è uno specchio,
un miraggio;
qui è uguale dire
sole o arancio
pozzanghera o cielo;
qui è uguale
agnello
o pane nero,
lingua di mare
o di terra.
(“I bambini sono venuti verso gli alberi di fico
per poter mangiare i frutti;
da qui posso vederli,
da qui posso udirli,
Ah, che bel giorno
per poter animare la vita!”)
Oggi
lasciate le finestre aperte
che il signore deve pregare!
Una feritoia,
la Murgia è una feritoia d’oro
d’oro bianco
che si specchia
di fronte al cielo.
Un erpice,
la Murgia è un erpice d’argento
che estirpa
il verminaio
nella lana delle nuvole.
(“I contadini sono andati nei campi
a tagliare il grano;
da qui posso vederli,
da qui posso udirli,
Ah, che bel giorno
per poter cantare della vita!”)
Oggi
per favore
lasciate le finestre aperte!
Oggi
per favore
lasciate le finestre aperte!


‘U TRABBUCCHE (22 ottôbrə d’u trəndanovə)
Na nòttə de chìitrə e trùunə
(lámbə ìində o cìilə d’a guèrrə)
rêtə ‘o stradonə d’a piccòlə
a reconə d’u mourə.
Na fəréitə ca jusckə
dôlcə, me stròzzə ngànnə,
d’o còrpə tou ca s’abbəgnascə
e ca u sèndə arrəspərè.
Ìində ‘o moute d’i pássə,
n’ômbrə affuchàtə de suldàtə
fáccə də bandéitə;
n’addorə də nêv ə
sopə‘a tèrr-a jársə;
po m’avvrázzə u màrə.
Traduzione
IL CAPANNO DA PESCA (22 ottobre del trentanove)
Una notte di pietre e tuoni
(lampi nel cielo di guerra)
dietro lo sterrato della “piccola”
a riparo del muro.
Una ferita lancinante
dolce, mi strozza in gola
dal corpo tuo che si soddisfa
e che sento respirare.
Nel silenzio dei passi
un’ombra soffocata di soldato,
faccia di bandito;
un odore di neve
su questa terra arsa,
poi mi abbraccia il mare.
SETTEMBRE
Dójə də finə Séttémbrə,
addaurə de chiouv-a préinə
i də mirrə nùuvə da rə candòinə.
M’arrecordə na uagnédd-a chiàinə
a l’appitə rèitə a u strataunə,
rə sckàimə sordə də rə uagneunə
da fourə a rə casərə d’u quartìirə,
povərə caserə də zappateurə,
ndò rə stéddə jérənə vaucə
də mùurtə, də sandə, də féstə.
26/11/2011
Traduzione
Una giornata di fine Settembre,
odore carico di pioggia
e di vino nuovo dalle cantine
Mi ricordo una ragazza incinta
camminare a piedi dietro lo sterrato,
le grida sorde dei ragazzi
fuori le case del quartiere,
povere case contadine,
dove le stelle erano voci
di morti, di santi, di festa.
NEVICATA
La volta di ruggine che accarezza i comignoli ai tetti, distilla come malva-
sia, i fumi ed i volti dell’inverno. Tra poco la neve coprirà l’antracite della
strada; tra poco con i passi infeltriti echeggeranno abbrunati nel crepu-
scolo, contrappunti di voci, canti e risa di mani rudi e fate, di fuorilegge di vento, di nomi sorpresi dal tempo.


ANDONJÈTTƏ
Andonjèttə, ca stasêrə
stè a ddè ffoure assolə,
assəttàtə tra u ləmonə
e a rosamaréinə
(A bavèttə de tèrrə
allèndə u fagugnə).
A sêrə də fìnə staggionə
tênə nu ziffrə de vocə:
assummègghjə a na cáppə də réisə
de criatourə lundànə.
(A bavèttə də tèrrə
arrəzzəcascə u musckə).
Chéss-a nòttə appêsə ‘o màrə
tə pupətascə parolə jágrə
də lágrəmə e bərlándə,
də jòcchjərə stutàtə nzéinə.
19/5/2008
Traduzione
Antonia
Antonia, che stasera
sei fuori casa da sola,
seduta tra il limone
ed il rosmarino,
(Il refolo da terra
spezza il favonio).
La sera di fine estate
ha un vortice di voce:
somiglia ad un mantello di risa
di bambini lontani.
(Il refolo da terra
accapona la schiena).
Questa notte sospesa sul mare
ti bisbiglia parole aspre
di lacrime e brillanti,
di occhi spenti in grembo.
UN AMORE DI ROSA
Mia cugina lasciò la scuola all’età di nove anni;
smise di svolazzare tra i campi del nonno
per trascorrere le giornate tra un angolo della cucina
ed il laboratorio di biancheria intima.
A quindici anni cominciò a ricamare il corredo
nei pomeriggi di maggio di campane in penombra,
alla domenica quando le sartine affollavano i cortili;
tutto andava “come sempre fu e come sempre sarà”.
In quelle sere d’estate del millenovecentosettantanove
aveva serpi di sette canne ad arroventarle il ventre
nel tramestio di lettere che le ragazze del quartiere
si passavano di nascosto dagli spioncini sulle scale,
mentre dalla gradinata attendeva i “giargianesi”
che le avevano tracciato itinerari negli occhi,
truccati da parole di cristallo ed ossidiana
annodate attorno a promesse di fili di perle.
L’avvolgevano il profumo di tigli e di lavanda,
mescolati all’aroma dei fioroni e dei gelsi appena colti,
della menta e delle piante di basilico, dell’odore terrigno
di lumache ed “acquasale” che inondavano le case contadine.
Fu un attimo: poi il vento dal Castello voltò il suo sguardo ad est
detergendo gli occhi dall’afrore di salsedine increspata dal favonio
ed impolverando gli altari delle chiese già ammanniti;
così, tutto tornò ad essere “come sempre fu e come sempre sarà”.
PUGLIA
Scarno profilo calcareo
di pietre violate
nella luce in declivio
del tramonto d’oriente.
Rugoso sorriso d’ambra
segnato dall’afrore di stagione,
cicaleccio di giorni immoti
che rincorrono il tempo.
Aromi aspri ed inebrianti
di terra,
di sangue e vita
avvinghiati a recessi pagani.
Bianche lenzuola appese
ad un raggio di sole
esile linea di confine
tra pensieri e ferite.
Miraggio che assale
nelle brume del giorno,
creature d’argilla
ubriache di storie e di ieri.

NOVECENTO
(da un’intervista ad Edit Brück)
“Quanta stella c’è nel cielo
quanta cattiveria nel cuore dell’uomo?”
Echeggiavano nei miei giorni invernale di bambina
i versi slavati di Petőfi
tra i muri di scuola scrostati;
attendevamo l’uscita per correre,
raccolti i capelli nei foulards ed i passi appesantiti dalla neve
incuranti
dei volti scheggiati dal vento dall’Alföld.
Amavo osservare nel pomeriggio
il destino imperscrutabile della Puszta
che adombrava i confini dell’Ucraina,
appena distinti dal fiato vitreo dalle stalle
ed alla sera dalle luci a petrolio della csàrda,
dove le famiglie condividevano con gli stessi accordi
le morse della storia
e l’alito della redenzione.
D’improvviso
vidi il cielo di cristallo della Tisza
abbrunarsi sotto un lugubre mantello corvino
come un’infinita notte polare,
sulla stessa terra di mille e più natali ormai straniera
e la faccia e le mani sporcarsi di fango,
in un’agonia di ingiurie,di risa di scherno, di sputi.
Sentì il vento di violini farsi macabro,
nel dissolversi del volto di mio padre oltre il filo spinato
in un pomeriggio senza più sera,
con addosso l’odore acre della mortificazione
e l’orizzonte inspiegabile prima, poi silente
della cenere nell’aria.
Vidi corpi nudi, piagati, sezionati
come cavalli in fiera dal respiro affannoso
ed avvertì il sapore dell’odio rappreso
sulle vesti e sulle cicatrici,
fino ad un’inattesa anestesia di mani pietose
a cingere le corazze ormai svuotate dei nostri accenti.
Ritrovai la libertà, ormai esangue
con le sue nuove itineranti celle,
a soffocare il mio impeto di abbracciare il mondo per inveire,
quando capì di essere solo nuova carne
per antichi rituali.
……………………………………………………………………...
Dopo sessant’anni
salpando di porto in porto a ricucire le vele,
mi accompagnano ancora quei versi slavati di Petőfi:
“Quanta stella c’è nel cielo,
quanta malvagità nel cuore dell’uomo?”
LA VISITA
Sairə də vuzzə
də finə agostə,
rə ciamareuchə annəsəlévənə
ndrəpəcannə,
appənneutə a na bavéttə d’ariə
ìində a la céstə.
Nzəghərdeunə na stascəddàitə,
la cambàin-a sordə də la Treneté,
na facci-a bianghə de fémmene,
na cappətéddə nérvə,
nu rəsariə.
Traduzione
Serata livida
di fine agosto,
le lumache annaspaavano
inciampando ,
appese ad un filo d’aria
nella cesta.
Improvvisamente una sferzata,
la campana sorda della Trinità,
una faccia bianca di donna,
una mantellina nera,
un rosario.
MEMENTO
Vertigini di un tempo gitano
sgranavano gli occhi alla notte
come sguardi fuggenti in attesa
del viaggiatore in dissolvenza.
Improvviso un eco di danze popolari,
carezza di lievi pieghe di vesti plebee,
riflesso te(pe)rso di memoria.
OLOCAUSTO GITANO
La fornace esalava acre odor di morte
ma sotto ignari cantavano la sorte
uguale da mille anni di angherie:la sorte
che anneriva il cielo di acre odor di morte.


TEATRO
Oggi mi è tornato in mente
nella penombra di novembre
quel pomeriggio di quasi trent’anni fa;
il tuo respiro affannoso
prorompente dalla scala condominiale
(in perpetua sfida
con il tuo asma bronchiale)
nell’ansia di raggiungermi in magazzino
prima che potessi sfiorare i fili
nel quadro elettrico.
Teatro
erano le tue stanze,
le tue giornate affollate
di plausibili orizzonti metafisici
in quei giorni di lanugine
dei polverosi anni ottanta;
ammiravo gli infiniti spazi
dei tuoi possedimenti
inestimabili
a qualsiasi stima di mercato.
Seppi per telefono
un giorno di marzo dell’altr’anno
che eri tornato;
il referto parlava di pochi mesi
di prugnole selvatiche
e di tabacco da masticare.
Ripensandoci oggi,
ho sentito scrostarmi di dosso
la vernice degli eventi.
Era teatro
ancora e sempre, solo, teatro,
la scena perfetta del congedo
rimasta immemore,
tra un volto di madonna illirica
e la processione dei creditori.

PUESÉJƏ DƏ VÌIRNƏ
Quánnə s’arrəcurdavə də chiddə ddéjə lònghə də vìirnə
pənzavə soprattuttə ‘a chiovə
ca affucavə i trasunnèddə d’u quartìirə
e jagnavə i vəgnàlə ddé vəcéinə.
S’arrəcurdavə précéisə-précéisə
i fémmənə ca scèvənə fuscènnə-fuscènnə
accomə u cìilə sə faciavə də chiòmmə,
téndə ch’i mourə sə dèvənə vocə ìində a còrtə
e i ffigghjə e e nəpotə s’accucchjèvənə lorə e lorə addé forə
a aduné i pénnə da sopə ‘e firrə.
P’i criatourə jèrrənə déjə də fèstə
mmèzzə a cuddə mərvəronə də vocə
ch’i ggiôvənə a cəcərəgghjé ìində o moutə addé fforə
(fòrsə dəcèvənə u rəsárjə o facèvənə
i mascéinə pə nan fángə sckatté l’òssərə)
mèndrə i vvècchje scèvənə arrəsədjènnə i vacéilə
pə méttələ sôttə e tèttə d’i lamiounə
pə tené l’ácquə p’a càsə (pənzavə ca jêrə strànə a véitə d’i ffémmənə,
chə tuttə cuddə tìimbə ca struscèvənə rêtə a ll’ácquə, mmèzzə a chiovə
e e fféilə a’ fundànə); po’ stənnèvvənə i rráchənə p’accumməgghjé i firrə,
a motə, a bəcəclèttə, i libbrə də l’attànə (ca cə mmògghjə a madònnə
facèvənə a palascéinə, scomodavə a tuttə a sacra famigghjə).
Tìimbə ddo jorə, scapulèvənə ll’ummənə d’a cambágnə e jêrə
na côrsə a prəparé da mangé accomə ‘a vəscigljə də Natàlə;
jêre na pəfanéje də zjànə, cuggéinə, də mònnə
rêtə ‘o Castiddə, də suldàtə e masciàrə, də stizzə də véinə,
də gastèmmə o guvèrnə, a guèrrə, a Mussoléinə e se cunzəlèvənə ch’a bənédəzzionə d’a chiovə e d’a musəchə.
N’o səndibbə mé parlé d’i ddéjə də solə;
“u solə assucavə a tèrrə e affagugnavə a càpə” dəciavə; na nòttə
də quécchə énnə ndràtə, préimə də pəgghjé sunnə, me dəcèttə
ca spəravə d’arrué a féinə də cuddə vìirnə, ca jêrə picchə e bbunə
ca nan vədavə téndə ácquə e l’árvərə acchəssì bérəfáttə.
U vìirnə spəccèttə e partibbə suldàtə;
mə chiamèttə u cumannéndə na matéinə də lugljə də fagugnə, pə ddirmə də chiamé a càsə, ca m’avèvənə cərcàtə.
Traduzione
POESIA D’INVERNO
Quando ricordava quei lunghi giorni d’inverno
pensava soprattutto alla pioggia
che inondava le strade del quartiere
e riempiva i vignali lì vicino.
Ricordava precisamente
le donne che si affrettavano
appena il cielo diventava color del piombo,
tanto che i muri si avvisavano tra loro
e le figlie e le nipoti si riunivano tra loro all’esterno
per ritirare i panni da dagli stendini in ferro.
Per i bambini erano giorni di festa
in quella a cuddə ridda di voci
con le donne giovani a chiacchierare fuori in silenzio
(forse recitavano il rosario o facevano
gli scongiuri affinché non ci si spezzassero le ossa)
mentre le anziane andavano raccogliendo i catini
per sistemarli sotto i tetti dei depositi
per avere l’acqua per casa (pensava che la vita delle donne era strana,
con tutto quel tempo che perdevano per l’acqua,tra la pioggia
e le file alla fontana); poi stendevano i teli per coprire gli attrezzi,
la moto, la bicicletta, i libri di suo padre (che se disgraziatamente
si fossero ammuffiti, avrebbe scomodato tutta la sacra famiglia).
Dopo un paio d’ore, rientravano gli uomini dalla campagna ed era
una corsa a prəparare da mangiare come alla vigilia di Natale;
era tutta un’epifania di zii, cugini, di mondi
oltre il Castello, di soldati e streghe, di sorsi di vino,
di bestemmie verso il governo, la guerra, Mussolini e si consolavano con la benedizionə della pioggia e della musica.
Non lo sentì mai parlare di giorni di sole;
“il sole prosciugava la terra e soffocava la testa” diceva; una notte
di qualche anno fa, prima di prendere sonno, mi disse
che sperava di arrivare alla fine di quell’inverno, perché da parecchio
non vedeva così tanta acqua ed alberi così rigogliosi.
L’inverno finì ed io partì per il servizio militare;
mi chiamò il comandante una mattina afosa di luglio, per dirmi
di chiamare casa, perché m’avevano cercato.
